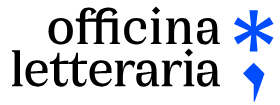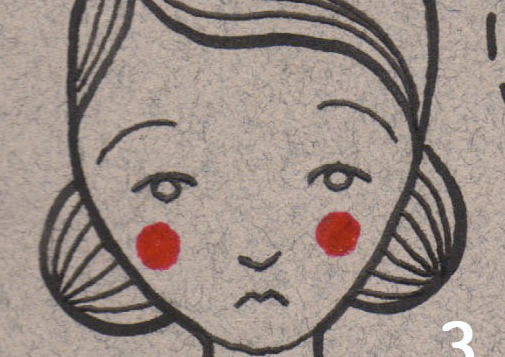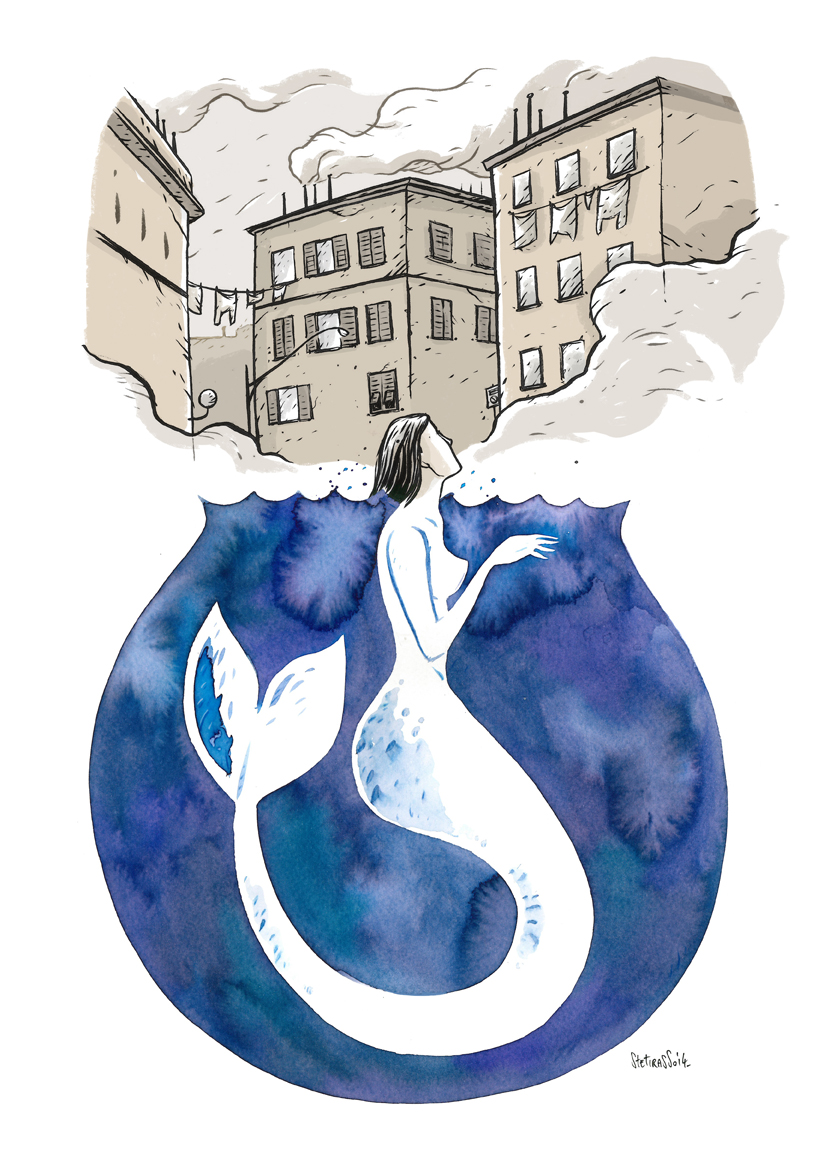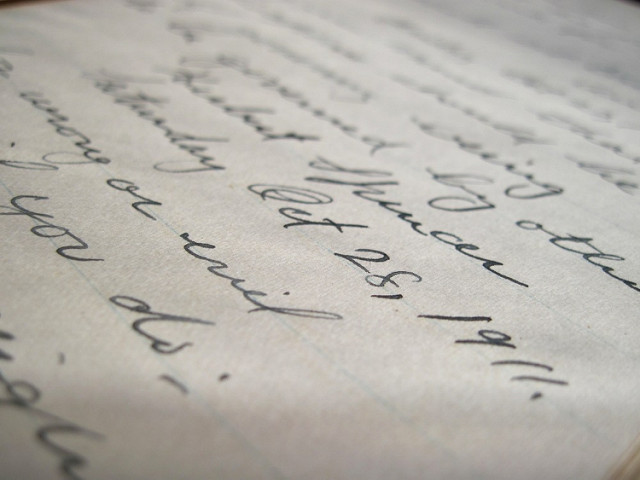Vorresti prenderla e descriverla, aggiungendo mille particolari, tutto ciò che vedi. E credi che, trovato il punto di vista giusto si possa andare avanti con un certo ordine. Ma è impossibile aggiungere qualcosa a Venezia, fossero solo parole. È lei che, per prima, ti deve scegliere. Venezia di Laura di Biase È lei che decide cosa darti, cosa concedere della propria essenza. E non per gelosia, o per diffidenza, ma perché l’intero sarebbe troppo per chiunque. E lei lo sa. Sono a Venezia per la prima volta. Prima di partire ho cercato di organizzarmi con una cartina: e se mi fossi persa? E se avessi girato e rigirato per le calli senza ritrovare la strada? Mi sento più sicura, adesso, e dal finestrino del treno mi tuffo nella laguna. È il suo primo avvertimento: non sono una città di mare, sono una città nel mare, lascia tutto, che ti porto io. Con il fiato sospeso supero il lungo tratto di ferrovia e Venezia mostra il viso familiare di una stazione come un’altra. Allora prima era suggestione, oppure ho solo immaginato, a furia di sentire nelle orecchie Venezia e il mare, Venezia e il mare, ad ogni giro di ruota. Finalmente scendo e trascino dietro di me la valigia. Anche lei ha delle ruote, piccole in verità, forse è per quello che non sento il loro avvertimento, lo stesso delle ruote del treno: Venezia e il mare, Venezia e il mare… Avevano cercato di dirmelo in tutti i modi, perché fossi preparata. Esco dalla stazione. Ho appena lasciato il mare dietro di me e me lo ritrovo davanti. Che strada può aver fatto? Non ci siamo detti ci vediamo là. Ed è arrivato prima lui. Bello scherzo, allora giochiamo. Mi guardo intorno e riconosco la mia strada, che corre parallela al grande canale e dopo poco se lo lascia alle spalle. Così questa volta vinco io, e sparisco. Ma Venezia sa attendere e sa dare tempo. Sa essere regina, senza essere dispotica e superba. Da vera regina sa accogliere chi arriva nel suo regno, non svela subito ricchezze e tesori. Lascia che ognuno decida quali siano i più preziosi per sé. Il tempo passa, e intanto il sole scende un po’, mitigando uno splendore che intuisco appena. È generosa, questa regina. Mi sa aspettare, finché mi ripresento al punto di partenza per continuare il gioco. La torta è talmente ricca, e bella, che si fa fatica a tagliarla. Ma per sentirne il sapore bisogna pur farlo e così scelgo una stradina, sottile, che non intacchi il tutto. Si comincia. La città mi prende per mano, e con lei inizio il mio cammino. Costeggiamo il grande canale, ci lasciamo alle spalle un ponte, arriviamo all’inizio del suo cuore. E a quel punto mi lascia andare. Mi volto, e rapisco con gli occhi l’immagine della strada fatta fin lì, nel timore di non saperla riconoscere. La città che mi ha preso per mano si è sciolta e si è fatta acqua. Davanti a me rimane la regina. Prendo un respiro, mi tuffo. Con me ho una cartina, la spiego, ma lei non ricambia e resta muta. Venezia è irriducibile, immensa grandiosità e ciò che ho in mano è troppo poco per contenerne l’anima. Ripiego il foglio e prendo un altro respiro, questa volta impercettibile, quello che basta per superare il primo ponticello. La corrente mi prende e mi spinge ad andare avanti, ogni passo un tesoro, ogni respiro una meraviglia. Davanti a me, dietro di me, e dentro di me. Venezia è ovunque, la sua essenza si espande all’infinito e riempie l’aria che respiro. Una corrente mi porta lontano. Torno sui miei passi, lei li incrocia, li moltiplica. Inizio ad avere il fiato corto. La luce, la gente, tutto in una volta. Dovrei tornare indietro, il ritmo è troppo alto. Non posso continuare così per molto. E la regina esprime la sua grandezza, accogliente. Attenua il suo splendore, lo offusca con une luce grigia, avverte che è l’ora di tornare, di invertire la marcia e mi fa da guida. Un tuono lontano mette fretta. La corrente si fa incerta, si ritrae, come una marea. Perdo l’attimo, catturata dal cambio di luce. Il buio si è fatto intenso, me ne accorgo, finalmente, e la corrente non è più con me. Sono sola. La piazza mi contiene e accoglie anche le prime gocce di pioggia. Qualche passo basta per capire che quella è la prima prova che Venezia mi regala. Mi guardo intorno e inizio. Da un ponte all’altro, seguendo l’istinto, seguo tracce invisibili. Guardo il cielo, non lo trovo. Trovo un quadro di centinaia di anni fa, luce di centinaia di anni fa, muri di centinaia di anni fa. Solo l’acqua è viva. Non so cosa seguo. Me stessa? La strada sarà lunga. Per confondermi, arrivano lampi da chissà dove. Bisogna sentire il proprio battito sopra quello del cielo. Seguo un ritmo, poi un altro. Ormai la pioggia si è fatta intensa e lava i colori, più vivi a dispetto dell’assenza di luce. La poca che è rimasta rimbalza da una pietra all’altra. Passando da una pietra all’altra arrivo a casa. Venezia ha mille voci. Nel silenzio ascolto quelle della notte, che mi tengono sveglia. È una città viva, e rimane viva in ogni istante. È bella. Intera. Piena. Le grida dei gabbiani mi avvisano che possiamo ricominciare a giocare in strada, come una volta. La città mi fa vedere come si fa e la seguo. Prima regola, cambiare. Cambiare occhi, polmoni, tutto, e di nuovo a cercare una strada per il suo cuore. Non mi perdo più. Ora che la conosco posso dare uno sguardo al foglio appena spiegato, adesso mi svela le sue vene e le sue arterie. Per sentirmi sicura basta guardarla negli occhi, non c’è più bisogno di proteggermi e la luce della sera resta piena. Niente cambio, questa volta. Scendo qualche gradino, mentre mi accompagna sulla riva, dove il grande canale cerca di salire sulle pietre che lo trattengono. Per provarci
A sei anni fui colpita da una fastidiosa forma di gastroenterite e, considerato che si era in estate, il gelato mi era proibito. Come se questa tragedia non bastasse, fui spedita a trascorrere le vacanze a casa di nonna Antonia, sull’Appennino lucano. Per par condicio, non fosse mai che si offendesse permalosa com’era, i miei dovettero promettere un mio soggiorno anche dall’altra nonna, quella materna, a Barletta sulla costa pugliese. Fu un’estate interessante, a suo modo. Conobbi bambini con accenti diversi e vite diverse, ma imparai soprattutto a conoscere le mie nonne; i nonni un po’ meno perché, pur essendo presenti, erano entrambi figure a lato. Nessuna delle due donne tendeva a sprecare parole: erano le loro case a parlare anzi a chiacchierare incessantemente. Le case delle nonne di Luciana Verre Nonna Antonia aveva una casa grande, sparsamente arredata e senza l’ombra di un soprammobile. Alla sera, con le finestre chiuse, le parole rimbombavano e rimbalzavano da una stanza all’altra e, di sicuro, non si potevano sussurrare segreti. Tutte le porte avevano pannelli in vetro smerigliato; quella del bagno mi creava non poco disagio considerato il mio problema di salute, ma la nonna ebbe pietà di me e mise una tendina. La cucina era la centrale operativa, ma le dispense, ben due, erano basi di stoccaggio. La più piccola approvvigionava i cibi giornalieri freschi; quella più grande, una vera e propria stanza, era per i cibi non-si-sa-mai-chi-può-arrivare La più piccola approvvigionava i cibi giornalieri freschi; quella più grande, una vera e propria stanza, era per i cibi non-si-sa-mai-chi-può-arrivare: in bell’ordine vi erano stivati damigiane di olio e di vino; vasi di verdure e di salame sott’olio; forme di formaggio coperte da canovacci; ceste con peperoni secchi; mazzetti di erbe aromatiche appese alle travi, in primis origano e l’adorata malva che Antonia raccoglieva sulla collina di fronte a casa. Mia nonna materna si chiamava Maria Sterpeta. Ancora oggi rabbrividisco all’idea che i miei avrebbero potuto essere meno illuminati e affibbiarmi quel nome in suo onore. In realtà, era un omaggio alla Madonna Nera dello Sterpeto , il cui Santuario sorge appena fuori Barletta. Donna enigmatica, votata all’apparenza, non si toglieva mai la maschera perché ciò che più temeva era il giudizio altrui, ma non perdeva occasione di criticare e spettegolare. Viveva in condominio all’ultimo piano, in un appartamento piuttosto piccolo ma carico di mobili e fronzoli. Nella sala da pranzo, c’era un mobile-vetrinetta talmente carico di cristalli che una notte decise di tirare le cuoia con un tale botto che ebbi problemi poi a prendere sonno per tutto il resto della vacanza. La polvere sui mobili era considerata fuorilegge e ogni superficie doveva brillare, ma si guardava bene dal farlo personalmente limitandosi a dirigere le sue figlie più giovani nelle pulizie di primavere quotidiane. Non c’era una vera e propria dispensa perché non amava cucinare e spesso si finiva per mangiare pane e pomodoro.
È una di quelle mattine in cui niente può andar male. In cui tutto gira per il verso giusto. Non sai neanche tu perché. E non lo sa neanche Emilia, con le dita delle mani ancora fredde dalla notte precedente. Andrai nel posto più noioso e triste del mondo, lo sai vero? E da sola, pure. Mamma mia, non ti invidio. Persone che le parlavano prima della partenza. Con tutti i loro consigli saggi e non richiesti. Emilia si stringeva nelle spalle, sì sì va bene. Come se fosse importante, ascoltare gli altri. E soprattutto, dargli retta. E così, niente. È partita… Incomprensibile felicità di Laura Caruzzo È partita come ha sempre fatto. Perché il problema non è partire; il problema è tornare. Ogni volta che si lascia alle spalle la sua città, la sua nazione, tutto l’amore e tutto l’odio verso casa si ingarbugliano in un nodo inestricabile, si intrufolano nel cassetto dei cd, non ne escono fino al ritorno. Che se ne stiano lì, incollati. Ha guidato su strade lunghissime, ha mangiato cose immangiabili, ha conosciuto persone alte e poco simpatiche. Si è perfino innamorata, una volta o due. Il tempo di una sera, in uno di quegli scenari da film romantico o d’avventura, uno di quelli che non si avverano mai. E poi via, senza voltarsi indietro, avanti verso tutto il nuovo e tutto il bello che sicuramente la stanno aspettando da qualche parte. E adesso è qui, in ciabatte e maglione, quello sformato, quello blu e bianco, con il vago retrogusto di un Natale norvegese particolarmente freddo. Davanti a una colazione così calorica e deliziosamente belga. Saluta con un cenno i signori della camera di fronte alla sua, una coppia di tedeschi sulla sessantina che leggono il giornale con una concentrazione fuori luogo per una mattina nebbiosa che in realtà è ancora un’alba. Non sa spiegarsi il perché, Emilia, ma davvero sente che niente potrebbe andar male. Né quel giorno, né in quelli a venire. Non è una sensazione chiara, è solo strana. Non le capita così spesso di sentirsi così inutilmente felice, o forse così felice per cose inutili. Per niente in particolare. È come se, per una volta, bastasse il semplice fatto di essere lì. Sprofondata tra giornali francesi, profumo di caffè, quella che non è nebbia ma solo foschia che preme sulle finestre. Sarà una giornata di sole. Sicuramente. Potrebbe anche fumarsi una sigaretta, prima di mettere definitivamente in moto il cervello, vestirsi, iniziare il solito tour culturale in cui si trascina (‘trascinare’, in realtà, non è il verbo corretto. Non rende l’idea di tutto l’entusiasmo che sicuramente le salterà in spalla una volta svegliatasi definitivamente) ogni volta che visita una città nuova. Sale nella sua stanza, un buco di una manciata di metri quadrati che però è riuscito a farla sentire a casa dal primo momento in cui ci è entrata. Prende le sigarette e nient’altro. Si chiude dietro la porta, percorre il corridoio salterellando, si lascia alle spalle quell’adorabile pensione. Cammina senza pensare a niente in particolare. Osserva i primi negozi che tirano su le saracinesche, i bar, gli uomini stretti in giacche pesanti che vanno a lavorare. Prova anche un leggero senso di pena per loro, perché andranno presto a rinchiudersi in un ufficio, in una banca, ovunque siano pagati per fare qualcosa che non vogliono fare Emilia no. Arriva in piazza. Sospesa in quest’atmosfera irreale, sonnolenta, senza contorni definiti. La sigaretta è quasi finita e le brucia l’indice. È allora che qualcosa nella sua testa pare scattare, o accendersi: è buffo, perché fino a quel momento non si era resa conto di essere in ciabatte e senza pantaloni nel centro della città. E fa anche un discreto freddo, a dire il vero. Probabilmente è il caso di tornare indietro. Vestirsi, magari. Tornare nel mondo dei civili e delle persone razionali. Abbandonare quell’attimo di pura e incomprensibile felicità. Poi, un altro dramma. Un urlo incrina quel silenzio di vetro. Un uomo le si avvicina di corsa. A pensarci, a ripensarci tempo dopo, Emilia non è per niente sicura che abbia gridato. O che le si sia gettato incontro con l’irruenza che le è rimasta scolpita nella memoria. Il signore belga si ferma davanti a lei. Le fa una domanda che perfettamente si adatta a quel clima surreale: non è importante la lingua in cui si esprime. Emilia lo capisce, e tanto basta. «Può allacciarmi la scarpa, per favore?» La risposta le esce dal cuore. Che in realtà non è una risposta, ma è un’altra domanda. «Perché?» Forse anche un po’ sgarbata. «Perché è l’unica cosa che non riesco a fare da solo», e sembra parlare con quel braccio che non ha, per dimostrare di non essere del tutto ammattito. Emilia non ci rimane male, non ci rimane in nessun modo. È normale. Si china e gli allaccia la scarpa.
Il Far West non è una vecchia storia con cavalli, cowboy, sparatorie dentro i saloon e bicchieri di whisky. Il West esiste ancora, il Texas c’è ancora, e dentro al Texas e le sue strade polverose può capitare di trovarci ancora qualche sceriffo oscuro a caccia di vendetta. Basta seguire le orme degli pneumatici, le impronte degli stivali, le scie di bossoli, ci vuole poco per caderci dentro con due piedi, come nello sterco… “Nel dolore” di Alessandro Zannoni Certo: i cowboy non viaggiano più per il paese in groppa ai loro destrieri, ma usano pickup scassati; le pistole però sono cambiate poco, e fanno sempre molto male. Questi sono i presupposti d Nel dolore (A&B editrice) di Alessandro Zannoni, autore nato a residente a Sarzana, con diverse pubblicazioni alle spalle. Nel dolore è il secondo romanzo che ha come protagonista Nick Corey, un italo-americano immigrato in Texas, figlio di una madre che parla una lingua mischiata tra inglese, italiano, il messicano e quella dei nativi. La prima volta Nick Corey è apparso nel 2011 in Le cose di cui sono capace, uscito con Perdisa Editore. La gestione della collana era già in mano a Antonio Paolacci (tra le altre cose, maestro di Officina Letteraria), erede naturale di Luigi Bernardi, e Antonio ne curò anche l’editing. «E con Stella come va». Alzo gli occhi dal piatto e la guardo serio. «Bene, ma’. Le cose vanno bene». «Cercherai anche stavolta di sposarla, io credo». «Credo che sì, quella è l’idea. Ma stavolta me lo ha chiesto lei», dico facendole un mezzo sorriso vincente. «Quindi sei tu quello che scapperà con i motociclisti», dice senza ridere. Nick Corey è sceriffo di BekereedgePass, è fidanzato con Stella, ragazza che è tornata da lui dopo averlo abbandonato all’altare e lasciato solo per sette anni, e ha un problema con l’alcol. Di recente, qualcuno ha ammazzato il suo unico e migliore amico Rudy. Quindi Nick ha anche una missione: trovare chi ha ucciso Rudy, e fare giustizia. A modo suo. Il romanzo è narrato in prima persona, da Nick, e il linguaggio è quello che ci si aspetta da lui: duro, amaro, masticato più volte come una foglia di tabacco. Dritto come la trama, un proiettile verso la fine; una brutta fine. «Pensi che finirà male, Nick?» «Credo proprio non ci sia alternativa, Stella». Ad alcuni, il nome di Nick Corey potrebbe suonare familiare. C’è un motivo, e ve lo spiega l’autore stesso, a cui abbiamo fatto alcune domande. OL: Come è nata l’idea di ambientare il romanzo nel Texas, e l’idea di utilizzare un protagonista italo-americano? Alessandro: È un’idea nata da una provocazione che avevo fatto a Luigi Bernardi su Facebook: si possono fare cover di canzoni arcinote, si possono fare remake di film straconosciuti, ma a nessuno verrebbe in mente di riscrivere un libro famoso perché verrebbe subito accusato di plagio. Bernardi venne fuori con questa proposta: avrebbe pubblicato chi si fosse cimentato a riscrivere un classico. Ci ho pensato un po’ su e mi sono reso conto che il mio classico per eccellenza, parlando di noir, è un libro scritto nel 1961, ma che ha una freschezza che sembra uscito dalla tipografia un’ora fa: Colpo di spugna di Jim Thompson. Del romanzo originale ho mantenuto l’ambientazione americana per svariati motivi, il più importante dei quali è che volevo poter giocare ad armi pari con gli autori d’oltreoceano – partono avvantaggiati, nell’inventare una storia, perché in America tutto è possibile e i lettori italiani accettano questo assioma senza storcere la bocca, cosa che non accade nelle trame ambientate in Italia, dove ti fanno le pulci su qualsiasi cosa -. L’idea di utilizzare un protagonista italo-americano è derivata dalla mia voglia di giustificare l’uso del nome di Nick Corey. Mi pareva davvero irrispettoso usare a cuor leggero un personaggio così iconico e riconoscibile, quindi mi sono immaginato che questo nome fosse in realtà davvero casuale, nato dalla traduzione dell’italianissimo Nicola Coretti, figlio di immigrati naturalizzati americani. E questa cosa la spiego perfettamente nel primo romanzo con protagonista Nick Corey. Il mistero della vita è che non c’è nessun mistero. Nasci vivi muori. Stop. OL: Come ti sei documentato su questi luoghi? Sono reali o di fantasia? Alessandro: Siamo esterofili, che ci piaccia o no, e l’America ci ha plagiato ben bene. Perciò credo proprio che ogni italiano di mezz’età abbia un ottimo background americano, grazie a libri, film e documentari, e con tutte queste informazioni non è servito andare in Texas di persona per ricreare una realtà plausibile e credibile. Ho scelto un luogo ideale dove immaginare la città di BakereedgePass, ho studiato alcune cittadine reali che sorgono in quella zona tramite Google Maps, e poi tutto mi è venuto naturale, tanto che nessun lettore si è lamentato. Anzi. E ad alcuni di quelli che mi hanno chiesto se ho vissuto in quelle zone, ho risposto di sì, per i primi quindici anni della mia vita, per non deluderli. In effetti credo di aver fatto un buon lavoro. L’amore e la vita sono una merda necessaria. OL: Perché “nel dolore”? Perché “l’amore e la vita sono una merda necessaria”? Alessandro: Per Nick il dolore è la condizione umana naturale. Lo ha messo alla prova, violento e inarrestabile, fin da quando era indifeso e innocente. Ha forgiato il suo carattere, inciso sulla sua vita. Nick non ha paura di affrontarlo, ci si butta a capofitto, perché sa che solo attraversandolo può raggiungere la sua pace. “La vita è una merda necessaria”, dice Nick, perché non può fare a meno di viverla, gliel’hanno data e non può tirarsi indietro, anche se ogni volta che si sbronza cerca di ammazzarsi ficcandosi la pistola in bocca. Sarebbe la via più breve per smettere di soffrire, ma c’è sempre un buon amico che lo aiuta a desistere, e un motivo forte per non farlo. Il motivo è l’amore, quello che prova per Stella, che crede sia la sua redenzione per diventare un uomo migliore e vivere una vita diversa e felice. In fin dei conti,
Noi non ce la volevamo passare la notte a Orio. Noi, con i nostri bagagli a mano, le valige piene di caciotte e capicolli come sul Torino-Reggio Calabria, gli zaini che sapevano di strada e la biancheria di sapone sciacquato, noi avevamo orari e mete precise: arrivo a Francoforte alle 22, recupero bagagli, baci, abbracci, e via, a casa. E invece… Noi che abbiamo passato una notte a Orio di Emilia Cesiro … E invece, quel giorno lì, che era luglio, era umido. D’estate. Capita. L’aeroporto rimbombava, completamente isolato dall’esterno. Decolli, atterraggi, annunci, chiacchiere, scherzi, bambini,musica dalle cuffiette, dagli altoparlanti, dai negozi. E poi il tuono. E poi la pioggia. Quella pioggia obliqua e dura, che danneggia le foglie e le ali. Tutti i voli, subito, come se non aspettassero altro, erano annullati. E c’era una grande calma. Un minuto prima tutti a guardar su, i monitor, gli orari, gli annunci,. E un minuto dopo, quasi in silenzio, quasi obbedienti, eravamo tutti in fila, quasi ordinati, ognuno verso la sua compagnia. Eravamo educati. Tutti noi, ormai, sapevamo che c’era di peggio, ma la rapidità e l’efficienza ci avevano stordito. E qualcuno vagava, non sapeva cosa fare. C’eravamo accalcati alle porte a vetro dell’aeroporto, imbambolati, col broncio o col sorriso, a guardare quella pioggia obliqua, da cartone animato, a sud di Bergamo, a guardare i taxi che passavano, ed eravamo sempre di meno, sempre di meno. E poi siamo rimasti in cinque, o quasi. Avevamo un posto sul volo delle 6 per Francoforte. Non eravamo gli unici passeggeri, ma… Gli altri, qualcuno aveva preso la macchina e era tornato a casa perché abitava vicino, qualcun altro magari più avvezzo, s’era procurato una stanza in albergo. Perché c’erano gli alberghi attorno all’aeroporto. Però noi no, perché noi avevamo la testa in altre faccende, nella pioggia, nel broncio, nelle caciotte, nell’Italia a piedi che è tanto bella, e poi qualcuno di noi, i soldi in più, per quell’albergo, per quella macchina che poteva farla dormire su un materasso e sotto delle lenzuola pulite, e niente, i soldi per gli imprevisti non ce li aveva. C’era chi, tra di noi, era stato derubato proprio quel mattino lì, prima di partire, prima di prendere il treno, prima ancora di chiudere la valigia, i soldi dell’affitto, i soldi del viaggio, e allora di corsa in banca, di corsa a denunciare e a chiudere la valigia. E chi invece, tra di noi, aveva girato a piedi e in autostop e non vedeva proprio la differenza tra una sala d’aspetto in stazione, le stelle e l’aeroporto. E c’era chi era innamorato e allora troppi stupori per pensare pure a dove dormire. Tra noi, c’era anche qualcuno che, con grande sapienza, aveva fatto solo viaggi sul ponte, senza cabina, arrangiandosi per terra, anche se non aveva più l’età. Così, alla fine eravamo rimasti in cinque, in tutto l’aeroporto. C’eravamo guardati, noi cinque, e avevamo i capelli di chi viaggia da troppo tempo, e c’eravamo scelti e come i musicanti di Brema, aveva detto qualcuno, che però erano in quattro, avevamo cercato un riparo per la notte. Tra noi c’era qualcuno che aveva visto la cappella e allora aveva detto che si poteva dormire lì, e tra noi era stata quella innamorata a tradurre e quello derubato di noi aveva detto “vediamo”, gli altri due che avevano camminato tanto avevano già capito e erano pronti, ma la cappella era piccola e piena. Allora quella innamorata e quello derubato avevano detto, corriamo al duty free, perché c’era solo un bar e non aveva più neppure le pringles, e bisognava mangiare qualcosa, perché le caciotte e i capicolli nella sua valigia erano per il suo amore, ce l’aveva detto per onestà, e non si potevano toccare, e noi avevamo capito perché l’amore è fatto di formaggio, aveva detto in tedesco uno di noi. Avevamo comprato l’acqua e i tuc e la cioccolata e avevamo diviso, e quello di noi che era stato derubato ci aveva raccontato quando usciva da calcio con i suoi compagni e andavano a comprare l’estathè e le merendine, e niente, gli era piaciuto e noi ci sentivamo così, che ci sorridevamo a vicenda, pensando tutti che era una cosa così strana e così piacevole che forse ce la saremmo ricordata per sempre. Era una cosa così strana e così piacevole che forse ce la saremmo ricordata per sempre. Ma non c’era dove potersi sdraiare perché c’erano dei sedili ma erano saldati a terra e avevano i braccioli. smembravano fatti apposta per impedire che qualcuno ci si sdraiasse, come nei parchi i barboni, ma quale barbone prende e arriva fino a Orio, che non c’è nulla se non l’aeroporto e le sue aiuole strettissime e gli alberghi che i barboni non li fanno entrare. E allora, come barboni, come adolescenti le ultime sere di agosto avevamo trovato un posto, uno qualsiasi che ci stessimo tutti, perché è un aeroporto non una stazione e gli aeroporti una volta erano posti sicuri, c’eravamo seduti e avevamo tirato fuori dalla valigia qualcosa di più pesante e qualche asciugamano e a avevamo dormito lì, uno accanto all’altro, ma non proprio dormito perché magari si perdeva l’aereo e c’era una di noi che si preoccupava che le guardie ci cacciassero e che allora sarebbe stato un problema ma chi tra noi era innamorato e chi tra noi era derubato e chi tra noi aveva camminato tanto sapeva che non era così, e allora noi c’eravamo abbracciati tutti, e alla fine un po’ avevamo anche dormito. E poi al mattino, che aveva la stessa luce della notte, perché negli aeroporti è come all’autogrill, c’eravamo tranquilli messi in fila, prima al bar, poi al check in e al terminal, quasi in silenzio, e sull’aereo eravamo tutti separati e all’inizio ci guardavamo sereni, poi abbiamo smesso. Ad Amburgo, ci siamo aspettati e ci siamo abbracciati di nuovo, in una luce ancora più asettica e strana e non ci siamo visti mai più.
Epilogo del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Epilogo di Sara Boero Alla fine ce l’avevano davvero, delle belle storie, quei nove smemorati. Mi liscio la punta della coda senza perderli di vista: Il bambino, senza fretta, si allontana in bicicletta; La pittrice e i suoi decori, ricchi d’animo e colori; Cavaliere immaginato, torna donna trasformato; Canta il vecchio musicista col suo buon cuore d’artista; Il barone truffaldino torna a casa col bottino; L’oste onesto è un’eccezione per le regole d’amore; Si confronta l’eremita con la svolta di una vita; C’era il boia e il suo mistero, s’è scoperto molto vero; Si dilegua la contessa che non era più se stessa. E io posso salutarli. Posso finalmente riprendere la caccia alla mia lucertola, che nelle ultime notti m’è sfuggita. La vedo tra le pietre del suo castello, la inseguo sulla terrazza. Si nasconde dietro a un vaso cercando di mimetizzarsi tra la lavanda e il timo ma questa volta non mi scappa sotto ai baffi: la fermo tenendola saldamente con la zampa. Non per la coda, come l’ultima volta, no: faccio per affondare gli artigli nel suo corpicino delizioso. E lei parla, con voce felina. La lucertola magica oppure no? “Gatto, anche sulla tua storia il sole sta per tramontare. Sono due giorni che ti scappo per fare indagini sul tuo conto. La mosca curiosa oppure no di me mi ha già detto tutto. Vuoi cenare o vuoi scoprire chi sei? A te la scelta.” Leggi i racconti di Apricale dall’inizio!
Decimo e ultimo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo! La contessa decaduta e il bambino americano di Angela Gambardella … 5, 6, 7, 8 perbacco! I rintocchi mi dicono che sono in ritardo oggi. Che sbadata! Devo correre in cima alla terrazza a salutare Perinaldo. Chiudo gli occhi e mentre canticchio nella mente una marcetta nuziale, un piccione in atterraggio mi sfiora la sciarpa avvolta intorno al collo. Subito dopo mi arriva una pallonata. Al mio solito strillo di spavento risponde una risata dalla piazza. Mi affaccio e ti vedo sghignazzare con insolenza. “Moccioso, vieni a riprenderti la tua palla!” Ti materializzi subito al mio cospetto e ti guardo con una smorfia di disgusto: da quanti giorni non fai una doccia? E quella macchia attorno al labbro è un principio di pubertà precoce o tracce paleolitiche di gelato al cioccolato? I capelli sono biondi ma aggrovigliati come dreadlock. “Non ti avvicinare, carino”, ti dico facendo un passo indietro e un sorriso di circostanza. Tu mi guardi con aria di sfida e cominci a canzonarmi: “hai paura dei piccioni, cosí grande!” Riconosco un accento americano e ti domando da dove vieni. Miami: mi spieghi che la Florida è un’appendice a sud degli USA. Che saputello! Indignata ribatto: “Beh certo, so benissimo dov’é la Florida. Ma cosa ti ha portato qui? Dove sono i tuoi genitori?” Dici di non ricordare nulla ma non sembra essere un problema per te. Ti volti di scatto verso il campanile e noti la bicicletta parcheggiata sulla guglia. Mi chiedi di custodirti la palla perché adesso vuoi andare a prenderti la bicicletta. Ne hai bisogno per raggiungere il confine francese: 2 ruote sono meglio di 2 gambe. Io invece prima vorrei recuperare dei guanti in lattice e del CIF per pulirti il muso. È così che si lavano i bambini, vero? Istintivamente chiamo la servitú in cerca di aiuto ma non risponde nessuno. Cerco di stabilire una relazione con te mentre tenti di parare i colpi di spugna. Nella colluttazione mi chiami maestra, poi ti correggi, teacher. Non faccio caso a questi dettagli, l’importante è renderti annusabile. Continui a parlare della Francia e mi pare di intendere che vuoi andare lí per raggiungere la tua famiglia. Ma perché ti hanno lasciato solo? Nel frattempo sei più calmo e pulito. Parli poco, ma quello che dici è deformato dall’accento, che comunque sembra forzato. Mi domando se tu non lo faccia apposta. Pian piano inizi a fidarti di me, forse perché sotto sotto in qualcosa ci assomigliamo. Ti prometto che farò tirare la bici giù dal campanile. Sembri più sereno adesso, e inizi a lanciarmi la palla, ma questa volta per giocare. Io son goffa ma ci sto. Inizi a fare sfoggio della tua sapienza e mi citi a memoria la catena montuosa alpina da levante a ponente, non omettendo il numero di pagina in cui inizia il capitolo. Nonostante la perdita di memoria temporanea mi sovviene il ricordo di essere una donna distratta. Eppure mi appare bizzarro che in America si studino i giovanissimi frammenti lapidei che svettano in Europa. Man mano che parli tradisci sempre più un gioco furbo che hai deliberatamente deciso di applicare. Fai finire tutte le parole con la W… Una sorta di alfabeto farfallino rivisitato. Con quell’accento bugiardo continui a chiedermi quando potrai avere la bicicletta appesa al campanile. Che sia questo l’indizio rilevante? Ti lascio lì e provo a chiedere aiuto a qualcuno in paese. Mentre cammino per le strade un cartello che indica il vicolo Ristretto mi attira a sé. Lì trovo uno zainetto azzurro dov’è disegnato uno stemma che racchiude una grande N. Deve trattarsi di una stirpe nobiliare a me sconosciuta, quindi di scarso interesse. Accanto c’è una scritta infantile: FORZA NAPOLI Apro la borsa e trovo i seguenti oggetti: un pupazzo dalle sembianze di Shrek vestito da calciatore con la maglia azzurra numero 10; un sacco a pelo logoro; 3 ovetti Kinder di cui 2 aperti e ricomposti ma senza la sorpresa dentro; 2 sorprese Kinder smembrate, evidente segno di scarso interesse del fortunato proprietario, oppure no; una borraccia con un liquido giallastro, forse succo d’arancia allo 0,3%; una cartina spiegazzata delle Alpi Marittime dove è stata tratteggiata a pennarello una pista ciclabile che parte dal Col di Tenda e arriva a Marsiglia passando per Apricale; un portafogli contenente ben 250 euro. Mi accorgo che è annotato il numero di un cellulare. Lo compongo speranzosa e all’altro capo della cornetta mi risponde una signora dalla voce afflitta: non ci metto molto a scoprire che si tratta della tua mamma. Povera donna, è disperata: sei scappato di casa in bicicletta due giorni fa per compiere un’impresa ardimentosa. Volevi arrivare fino a Marsiglia per vedere la semifinale degli europei. E hai pure pensato bene di spacciarti per americano, riciclando le quattro parole in croce che hai imparato alla TV! Un piano a prova di bomba: ma stasera qualcosa mi dice che la partita te la perdi… Leggi l’epilogo dei racconti di Apricale! Leggi i racconti di Apricale dall’inizio!
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. La Non-moglie la giornata di Angela Sotto la vernice del presente, una donna non-moglie e non-madre è guardata come un oggetto ignoto, un ufo sociale. Il ruolo di ufo può suscitare senso di meraviglia, come nei film di fantascienza, ma talvolta origina diffidenza e pregiudizio. Ne riconosco lo sguardo quando la conversazione s’interrompe, poco dopo il mio atterraggio, nel momento in cui appare chiaro che non ho una fede al dito e non ho una prole speranzosa del mio ritorno a casa. Uno sguardo come se avessi disertato qualcosa e che mi sorprende sempre. Non avevamo già superato questa storia dei ruoli? Manco per niente. Anzi, insospettabili amiche coetanee, divorziate e nei guai con il lavoro, parlano del loro passato matrimonio come di un progetto cui hanno creduto e che hanno coltivato in gioventù, senza dedicarsi ad altro – lavoro, carriera, interessi. Il ruolo di “moglie di…” appare nei loro discorsi carico di una pienezza esistenziale che è stata in grado di celare altre possibilità e la cui perdita, adesso, le sconcerta. Lavoro come insegnante in una scuola media. Affrontare ogni giorno una quarantina di persone diverse non è semplice. Anche perché io sono la nemica e non devo farmi impallinare. Suona la campanella. Si va in scena o in trincea, secondo le classi. In entrambi i casi, mi considero fortunata perché posso osservare agevolmente persone molto più giovani di me. Saluto alunni e alunne, che mi ricambiano con un’espressione del viso o una battuta peculiare, a volte con un silenzio speciale. Se ci si sofferma su di loro, queste ragazzine e ragazzini promettono bene. Non è vero che sono pessimi, come dicono tante persone adulte e invecchiate male. Non è vero che non capiscono nulla. Siamo noi che pretendiamo molto da loro ed esigiamo che, in un mondo in delirio, siano perfetti, responsabili, irreprensibili. Nel nostro mondo. Irreprensibili. Nel nostro mondo, dove tutti si-prendono-le-loro-responsabilità e poi le trattano come zerbini. Mi viene da ridere. Penso alle colleghe, non tutte per fortuna, subito pronte con parole dure verso di loro. Le capisco anche, magari dopo tanti anni di lavoro avrò anch’io esaurito la pazienza e la comprensione, oltre che le energie, ma si sono da tempo dimenticate cosa significhi avere tredici anni e dover stare seduti per sei ore. Non era facile nemmeno per me, che ero seguita da genitori attenti senza i quali non sarei riuscita a ottenere-buoni-risultati. Che poi, l’unico risultato davvero importante è essere felici. Alcuni ragazzini e alcune ragazzine non lo sono. A volte, mentre spiego qualcosa, una parte di me si diverte a immaginare come diventeranno. Sicura che non indovinerò mai. Arriva una circolare da dettare: “Il Dirigente Scolastico… i professori… i coordinatori… i rappresentanti”. Loro mi guardano, ghignando sotto i baffi. Sanno cosa sto per dire. E infatti. “Siamo quasi tutte donne e questi nomi sono tutti maschili. Io sono una professoressa e una coordinatrice”. Proteste scherzose da parte di alcuni ragazzini: “È giusto, siamo più importanti noi maschi!” Le ragazzine rintuzzano i compagni e li accusano di essere i soliti che non capiscono niente perché ragionano “con quello”. Dico loro che si tratta di uno stereotipo. “Però un po’ è vero”, ribadisce un’alunna, “non pensano ad altro”. “Tu non ci pensi?” “Be’, sì, ma loro… e poi io non sono mica una di quelle!” Affermo che ogni essere umano, donna o uomo, ha dei desideri e che questo per una donna non significa essere una-di-quelle. Non è facile. L’antico pregiudizio è inciso nelle loro menti, tenace e sempre nuovo. E la sorpresa mi coglie di nuovo. Non avevamo abbandonato queste prigioni? Quando sono state ricostruite? A pensarci, non sono mai state demolite davvero. Una collega mi domanda se posso sostituirla il giorno dopo. Deve andare dal pediatra e suo marito non può perché ha da lavorare. E lei che sta facendo? Coltiva compiti in classe per hobby? Le dico che la sostituirò. Suo marito ricopre un importante incarico in un’azienda e non può prendere un permesso per seguire i bambini. Ovvio. Naturale. Quindi il lavoro di lei è meno importante. E anche il mio. Mentre i mariti costruivano carriere da dirigenti nelle multinazionali, molte donne sceglievano l’insegnamento come ripiego, per potersi prendere cura della famiglia. Terza sorpresa. E’ ancora giusto così, per alcune. Il pomeriggio, correggo compiti in classe. Lotto contro gli anacoluti. E penso agli anacoluti del mondo, alle contraddizioni in cui siamo tutti e tutte invischiate, ai suoi pensieri torti. Abbiamo fatto dei passi avanti? Il mio compagno ascolta e condivide le mie riflessioni, e mi sembra già un magnifico dono. Mia madre è più ottimista di me e ne tengo conto. Forse ha ragione.
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. Un lunedì la giornata di Elisabetta Non voglio svegliarmi, non ancora. Devo finire il mio sogno. La sveglia si insinua maligna, a volte con una musica dolce piena di promesse; quasi sempre, invece, snocciola un concentrato di notizie volte a suscitare malumore. La disgrazia del giorno, l’aumento delle tasse, la dichiarazione insensata e autocelebrativa del politico di turno. Mi alzo, già consapevole che anche oggi arriverò in ritardo a lavorare. Del resto, non posso uscire di casa senza aver fatto colazione, cambiato idea un paio di volte su come vestirmi, dato da mangiare al gatto, controllato che le finestre siano chiuse, trovato chiavi di casa e cellulare, che si nascondono sempre quando li cerchi. Speriamo che la Capa sia di buonumore, oggi, altrimenti saranno rimbrotti generalizzati per tutti. Non che mi importi tanto, ma anche questo peggiora il tono dell’umore. Mentre lavoro, cresce sempre di più la sensazione di pestare l’acqua nel mortaio: non c’è una fine né un inizio, ma soprattutto nessun ritorno su quello che fai. Pazienza, che tanto mi tocca questo fino alla vecchiaia. Intanto penso già a quello che devo fare nel tragitto verso casa e poi a casa. Comprare il caffè solidale, prelevare i soldi al bancomat, far la spesa sotto casa, controllare le scadenze, pagare on line la multa per divieto di sosta di mia figlia, ritirare il bucato asciutto e metterne su un altro, pensare a cosa faccio per cena, sedermi per un quarto d’ora e poi mettermi a cucinare. Incombenze nel vero senso del termine, che gravano sulle mie spalle costantemente contratte. È un lunedì, ma potrebbe essere anche martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e, parzialmente, anche domenica, giornata in cui ormai mi tocca la visita alla suocera ultraottantenne, che, ostinatamente, vuol restare a casa sua da sola. Così mi ha delegato, bontà sua, la gestione della sua vita, badanti e relative bizzarrie comprese. Sabato no: finalmente posso sognare fino alla fine e concedermi tutto il tempo che voglio. Il tempo è scivolato via come una goccia di pioggia sui vetri, e a quasi sessant’anni – che pensiero orribile – a volte mi chiedo se valga la pena metterci tanto impegno. Poi penso alle mie bambine, che sono pezzi del mio cuore e dico che sì, ne è valsa la pena.
Nono e penultimo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo! Il boia in attività e la contessa decaduta di Clara Negro Bastardo d’un gatto! Già, cosa diavolo potevo aspettarmi da un animale? A me, un boia, essere accoppiato a una contessa, dover trovare addirittura il suo passato. Che tu sia una contessa non ci piove. Ti guardo, stai sola in mezzo alla piazza, il naso all’insù, fin troppo all’insù. Come lo chiamano? Alla francese? No, all’insù come quelli che hanno la puzza al naso, narici strette per non sentire l’odore dell’umanità. La puzza della paura e del sangue. Che io amo invece. Ti muovi e cammini, la testa alta, lo sguardo che non sfiora mai terra. Guarda che così rischi grosso, bella mia, le pietre irregolari sono ingannevoli, non vorrei sbattessi il tuo bel nasino a terra. Ti seguo verso il Castello della Lucertola. Mentre sali sorridi, come il viaggiatore che, lontano da troppo tempo, torna a casa, e ritrova la sensazione di posti conosciuti. Tentenni sulla porta del castello, ti fermi a guardare per essere sicura che nessuno ti segua. La porta è sbarrata: oggi non è giorno di visita. Appoggi le mani bianche allo stipite scuro, mormori qualcosa poi ti afflosci, come se, quell’abito che porti con sussiego ed eleganza, si fosse improvvisamente svuotato di te. Ti afferro prima che tu cada sulle pietre calde di sole. Cosa credi bellezza che ti lasci andar giù così, a peso morto? Mi basta un braccio per sollevarti, un corpo troppo leggero, quasi fossi fatta di fumo e non di carne, ossa e sangue, cose di cui io son esperto. Mi siedo nell’umidità dell’ombra, in modo tu possa sentire l’aria fredda che sgorga dalla bocca della cantina, e ti trattengo tra le braccia. Sento che stai riprendendo coscienza, apri gli occhi e mi vedi: “Chi sei?” Non scappi, non ti agiti, non urli come mi aspettavo, mi guardi dritto negli occhi. “Chi sei?” ripeti. “Ecco, questo è il mio problema, proprio uguale al tuo. Io sono un boia, e tu una contessa, mi sembra di aver capito.” Sollevo la mano e l’avvicino al suo collo bianco. “E questa cos’è?” “Questa cosa?” “La cicatrice intendo.” Non finisco la frase che sei già in piedi. “Di cosa parli? Quale cicatrice? Sono i tuoi occhi di boia vecchio e pazzo a farti vedere cose che non esistono?” In quel momento la porta del castello si apre. È il custode che finisce il suo giro di ispezione e torna a casa. Lo spingi di lato e sgusci nell’androne buio. Ti seguo e il poveretto mi grida dietro:“Ma dove va? Oggi è chiuso.” Non mi fermo, entro e sbarro la porta con il ferro morto. Sono sicuro che qui dentro è successo qualcosa. I tuoi e i miei passi rimbombano nelle stanze, sulle mattonelle decorate, tra i mobili antichi, nella corsa rovesci qualche sedia, cadono oggetti che non posso fermarmi a raccogliere. Stanza dopo stanza, corridoio dopo corridoio, sembra persino tu sappia dove andare, come cercassi rifugio o fuggissi da qualcuno. “Fermati!” Grido. L’ultima camera si apre su un giardino pensile. “Dove sei caruccia? Che ti nascondi a fare? Mica avrai paura di me? Sono il boia, ma tu che hai da temere?” “E che ne sai? Magari potrei essere la prossima condannata alla forca, al ceppo.” “Ehi sei rimasta indietro bella mia! È finita l’epoca delle barbarie. Adesso civili come siamo usiamo i vapori di cianuro, le iniezioni letali. Niente più sangue, purtroppo.” “Va via boia o mi butto. Giuro mi butto di sotto.” Si avvicina alla balaustra. “Me ne vado, me ne vado. Tu però non fare sciocchezze!” Le tende a fiori svolazzano, gonfie di brezza della sera. Anche la luce si smorza, tenera e rosata illumina i ritratti alle pareti. Mi avvicino a un dipinto, una cornice dorata chiude un paesaggio marino attorno al corpo di una donna sottile, flessuosa, lo sguardo alto, buttato lontano sull’orizzonte e il naso…il naso all’insù. Troppo all’insù. Leggo il cartellino alla base del quadro: Cristina Belforte, contessa di Apricale,15 maggio 1840 – 8 settembre 1865. Cristina Belforte, sei tu allora, tu: la contessa di Apricale. Mi avvicino alla finestra, sei ancora là: il viso rivolto alla valle, le spalle curve di un peso senza memoria. Torno al dipinto, accanto c’è un tavolo e sopra al piano lucido libri antichi, documenti dai margini consumati e un quaderno. Lo apro: pagine ingiallite, fitte di una scrittura leggera e incerta. Leggo e la stanza si riempie di voci e di ombre, il passato diventa presente. Apricale, 12 marzo 1865 Il ventre si è gonfiato, ne spio la curva nel grande specchio della stanza. E faccio del mio meglio per schiacciare la protuberanza maligna con i palmi aperti. Che fare? Alfonso, mio marito, manca da otto mesi. Non posso fargli credere che sia frutto dei suoi lombi. E poi i soli ricordi che mi ha lasciato sono i segni della sua violenza. A lui, la colpa del mio tradimento. A lui e agli occhi e alle mani di Carlo. Alle sue parole di miele, al suo tocco leggero. Scorro veloce le righe: senti dentro di te quell’essere indesiderato e lo odi. Non sarai mai una madre. Apricale, 12 luglio 1865 Tutti al castello lo sanno e tutto il paese ne parla. Li odio. Odio me e lui, e Carlo Ratti che è felice, invece. “Fuggiremo lontano!” Mi dice. Ma dove? Gli dico. Di che vivremo? “D’amore, mia adorata, d’amore e di baci.” Povero pazzo! 8 agosto 1865 È arrivata notizia: Alfonso tornerà prima di Natale. Per allora dovrebbe essere nato. Lo sento scalciare sempre più forte. Ho costretto Mariuccia a legarmi stretto il ventre con una fascia. Stringi, tira forte. Troppo tardi, non servirà a far scomparire la pancia, ha detto. Si avvicina
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. Due lune la giornata di Laura Ora sono a casa, la mia giornata si sta avvolgendo ed è piena, come una luna che deve riuscire a contenerne due, una luna piena doppia. Tutto quello che faccio voglio che stia in qualche angolo, in qualche spazio, in un contenitore estensibile. Mi sono alzata presto. Oggi: uscita con i miei alunni. Uno sguardo alle figlie, che solo a pensarle un tasto automatico parte e inizia a far scorrere il nastro, fatto di fotogrammi già pieni e di altri ancora da impressionare. Quelli impressionati hanno tanti colori, suoni, toni. Quelli ancora vuoti hanno riflessi che basta poco a cambiare. E mentre esco attacco un altro passo, quello che mi porta al lavoro, sull’autobus do il via con il mio collega al prossimo possibile sciopero della scuola, sì o no. Cosa s’ intende per scuola, cosa per società, cosa per… e arriviamo. La sera prima non sono riuscita a scrivere, mi devo mettere a studiare, è deciso. Porto con me le mie forbici invisibili, mi servono per il mio passatempo preferito, ritagliare. Ritagliare tempo per me, trovare piccole asole, scucire un po’ qua e un po’ là e aggiungere delle tasche, dove mettere parti di me stessa. La mia giornata intanto scorre. Faccio turno doppio. Ma non mi spetta, ma non è previsto che non mi spetti. Mi spetta o no? Intanto lo faccio e buonanotte. Arrivo a casa e trovo ad attendermi qualcuno, o meglio qualcosa. Le cose che mi hanno salutata quando sono uscita stamattina: no, non posso, oggi sto fuori tutto il giorno; non posso neanch’io, Conservatorio e Università, ma come faccio? E io ho già dato, una riunione che mi aspetta. E poi devo fare la spesa. Allora le cose mi si affezionano, mi aspettano affettuosamente, mi scodinzolano quasi, quando arrivo a casa. Quanto gli sono mancata! Il gatto viene trotterellando in ingresso, quando mi sente, e si butta per terra, ama che gli gratti la pancia. Arrivo con le pile sul rosso, magari diciamo ancora sull’arancione, il rosso arriva dopo cena. E non è che rosso di sera buona giornata si spera. E due lune sono troppe, ci vorrebbero delle nuvole a coprirne almeno una.
Paragrafo Centosettantacinque: La fornicazione contro natura, cioè tra persone di sesso maschile ovvero tra esseri umani ed animali, è punita con la reclusione. […] Eldorado di Camilla Tomiolo Quando è stata l’ultima volta? Due sere fa. E come è stato? Le luci sul palco, il semi buio intorno, euforia nelle gambe, paura nei polsi. E poi? Lo sai: prendi il respiro. Ti tuffi. È qui che ti voglio. Ci sei riuscito? Sì. Di nuovo. Sì! E che mi dici dei pezzi di faccia da gentleman che ti sei portato dietro? Li abbandoni pian piano. Un pezzo al guardaroba, un pezzo sotto a un tavolo, un altro pezzo sul bancone del bar. Qualche frammento microscopico sul vestito nero della folla. Tutto il trucco del mondo non basta mai. No, hai ragione. È un processo più fondo, quando cominci a dimenticarti che sono i tuoi gli occhi che guardano, allora sei libero: sei dentro la folla. Centinaia di persone che sudano, ballano, si baciano. Si spogliano. Scopano qua e là. Sì. È un’altra Legge lì dentro. Maschile femminile. Femminile maschile. (ride) Mostri! (pausa) Se potessi liberarmi di te senza perdere me stesso. Giusto e sbagliato. Bianco e nero. Verità assolute… (ride) Tradizione. Ciò che è sempre stato non può essere cambiato. Il pensiero si disfa di fronte alla realtà. La realtà è una e tu devi rispettarla. Tutto si trasforma. Questo non sono io. Io non sono te. L’unico peccato che ho mai commesso è di pensare di non sapere chi sono. Mi sono messo un paio di calze velate l’altra sera. Ero eccitato e nello stesso istante arrabbiato con me stesso. Nello stesso istante. L’eccitazione dal basso si espandeva, arrivava a sfiorare la rabbia che a quel punto non aspettava altro che scatenarsi contro di lei, ma, senza rendersene conto, tutto ciò che faceva era mescolare se stessa alla voglia: dare forza alla spinta. Le labbra le ho fatte di un rosso violento, troppo acceso per restare dov’era: nel cuore della notte mi è scivolato fuori dalla bocca, una strisciata che mi ha allargato il sorriso. (ride) O forse un livido. Un bacio senza amore. Un morso. Rosso innaturale diventerà viola. Non capisco perché lo fai. Cosa non capisci? Libertà o distruzione? (ride) Tu vuoi offenderci. (ride) Rispondi. Che cosa vuoi?! E tu? (pausa) Chi sei? Chi sei piccola voce che riempi le nostre teste? Da dove arrivi? Da quanto sei qui? (silenzio) Sei la morale? O sei la Legge? Di quale Dio? O sei solo un uomo, come me? Nemmeno. Tu sei un occhio impreparato che tenta di spiare l’universo da un buco di una serratura. Che cosa credi di vedere? (silenzio) Che cosa hai visto? Dillo! Che cosa credi di avere visto?! (silenzio) Non tutto ciò che non conosci è sbagliato, sai? Forse è perfino il contrario! Ci hai mai pensato? Eh?! Che cosa senti? Rabbia? Sì! Vorresti infilare tutto questo fango di nuovo dentro al secchio! Sì! (pausa) Io ho questo senso sulla lingua, che non è il senso comune, è la colpa. Io ho fame. E non posso farci niente. La mia anima c’è, e c’è, e c’è. Riesci a capirlo? Forse mi sono innamorato. Guarda come ti sei ridotto. Mi sono innamorato della libertà. Tutta questa libertà è solo una follia. Tu sei cattivo. Ero affamato. Avevo sete. La sete che avevo era una lama rovente. Ma volevo la luce. Volevi il buio. Volevo la luce. La tua luce è una terribile illusione. (silenzio) Tu non sai amare. È quello che dicono. Ma nessuno mi odia più di quanto io mi odi. Dentro di me c’è una voce che parla come loro, sei tu. È la mia guerra, è proprio qui. Se perderò… la perderò solo qui dentro. Tu amami piuttosto. Mostrami l’Amore. Si può insegnare? E se lo insegni a me, imparerai anche tu? Dicono che si deve educare al bene attraverso il male. Che siamo deboli. Tollerati. Per quanto ancora? (pausa) Se solo potessi essere quello che sono. Ma io non posso sopravvivere a te. E tu a me. Solo uno, solo uno di noi può restare. (pausa) Io non voglio morire. Monologo teatrale scritto da Camilla Tomiolo, rappresentato durante l’evento Blackout – giorno della memoria al Munizioniere di Palazzo Ducale il 29 gennaio 2017, organizzato da Arcigay Genova.
Un calcio alla porta e sono dentro. La guardia con un occhio blu e l’altro grigio grida: “hey tu, invertito, in piedi!”. “Si, signore”, risponde Hans, con quella sua vocina sottile da topolino. “Qui! In ginocchio!”. “Si, signore”, il topolino si mette giù, in ginocchio, con la testa tra le mani. Eldorado di Michela Armenia Il trucco, è non reagire, recitare una parte. E io sono bravo a recitare, Sei nato per questo mi diceva mia madre. Meine Liebe. E’ semplice. Io faccio la valigia e pouff, me ne vado. E mi infilo, piccino come sono diventato, in quella fessura nell’asse di legno che ho un palmo sopra la faccia. Proprio lì, sotto le ossa del bacino di Otto. Prima il polso, poi il braccio e la spalla, poi l’altro polso, l’altro braccio e l’altra spalla, e poi qualcuno da sotto mi spinge su, sotto i piedi, e appoggio le mani su travi di abete ruvido. Abbasso anche io la testa, e annuso questo palcoscenico e mi alzo in piedi sui miei tacchi di vernice, neri. Sistemo le calze, velatissime, l’abito è quello di raso, rosso, con lo spacco, profondo. I pendenti di brillanti e il decolletè, liscio. Le perle dorate. Sono pronta. C’è il mio pubblico, qui, all’Eldorado. Il giovedì è la mia serata, la serata di Evah. Ho messo un velo di cipria sotto il rossetto, me lo ha consigliato Constance, così non sbava, nel caso ti sudassero i baffi sotto le luci forti della scena. Constance, l’unica puttana ebrea di cui ti potevi fidare. Piccolo angelo, c’eri anche tu su quel vagone. Stella gialla a te, triangolo rosa, a me. A me, che nemmeno piace il rosa. Non ha passione. Rosso doveva essere. Rosso, come l’inferno. Come questo vestito di raso che scivola sulle mie gambe e odora di tabacco e di rum. La parrucca è quella nera, ondulata. Sono pronta, tra il pubblico ci sono tutti quanti, ancora una sniffata di cocaina. Sapessi, Guardia, come fa star bene un po’ di coca, una sigaretta e un bicchiere di vino rosso. Mi aiuterebbe, sai, Guardia, quando ti chiedo una porzione in più di sardine e tu mi spingi la faccia contro il tuo grosso cazzo ariano, non sai quanto mi aiuterebbe un po’ di coca, una sigaretta e un buon bicchiere. Inizio a cantare, ieri si è esibita Marlene, l’Angelo Azzurro, Dietrich su questo stesso palco e adesso tocca a me, ho cancellato le mie sopracciglia, con la cipria, e le ho ridisegnate sottili, due sorrisi sottili, all’ingiù, proprio come le sue. Ma il boa di struzzo no, io no, io sono Eva e voglio che mi vedano per bene, la mia faccia, la mia bella faccia tutta intera, con i miei zigomi forti e gli occhi allungati. Le mie gambe. E la mia voce. Inizio la mia canzone. Ridi, Guardia? Ridi della mia testa rasata da un barbiere distratto? dei miei capelli castani e lucidi lì per terra, sopra mucchi di capelli di criminali, pazzi, di comunisti, ebrei e zingari? Ridi dei miei denti che sembrano così grandi e gialli tra queste labbra cotte dal sole e dalla neve, tagliate da solchi dove scorre sangue e pus? Ridi delle mie mani che non sanno stare ferme? E’ il mio segreto, sai Guardia? Io sento la musica, io la seguo sulla punta delle dita. Dovevo stare più attento, oh lo so. Lo! So! Me lo diceva sempre lo Zio, sai Guardia? Mi diceva che dovevo essere un finocchio discreto. Tu puoi essere un finocchio ma non puoi vivere come un finocchio, diceva lo Zio. Non devi nemmeno sognare o immaginare come un finocchio. Il caro, vecchio, Zio. Era così infelice povero Zio, si eccitava come un bimbo davanti a un treno a vapore, per uno sguardo rubato, per una mano sfiorata, Ogni sua stretta di mano era il ristagno di una carezza, povero Zio. E ogni suo respiro, il ristagno di un grido. Io, Io la volevo tutta, questa mia vita, tutta così, come mi chiedeva di essere vissuta, io non volevo rosicchiare gli angoli. Io ho baciato, abbracciato, ho toccato e scopato così tanto e non ho mai dovuto pagare, sai Guardia? Ma certo che lo sai, quanta bella carne c’era attaccata a queste ossa. Io sono pronta, ora inizio la mia canzone, in prima fila c’è Christopher, che mi sorride, il mio piccolo Chris, con quel suo accento inglese, era adorabile. Avrei dovuto seguirlo, “Scappa con me a Londra”, mi ripeteva, “la mia vita è qui, all’Eldorado, dolcezza”, gli rispondevo. Chissà dove sei con i tuoi occhi verdi, mio piccolo Chris. Chissà se ci pensi ogni tanto… ti ricordi? Berlino. 1930… autunno. Io ti posso ancora sentire mio dolce Chris, nelle mie mani c’è il ricordo della tua pelle, nelle mie dita, la linea del tuo profilo. Mi sorridevi, dalla prima fila. Cherie. “Qualcuno porti via Hans”. Vogliono che ce ne occupiamo noi dei corpi. Non ci vogliono toccare. Non c’è nessuno che ci tocchi qui. Per noi con il triangolo rosa non ci sono più abbracci o carezze. Noi con il triangolo rosa sappiamo che siamo ancora vivi perché quando tossiamo, pisciamo o caghiamo sentiamo fitte di dolore. Quando ci bastonano le gambe se non scattiamo subito al suono della sirena, Fitte di dolore quando ci spingono per terra per vedere quanti secondi impiega un invertito a cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, cadere. Il dolore dell’amore che se ne va, E’ la mia canzone. Meine Liebe. Mi dicevi “Scappa con me a Londra” “La mia vita è qui, all’Eldorado, dolcezza”, ti rispondevo sempre. Mi dicevi con il tuo adorabile accento inglese, mi dicevi “Questa non è la Terra Promessa” La Legge, mi dicevi, “We are bandits”. [Voce fuori campo] Paragrafo Centosettantacinque: La fornicazione contro natura, cioè tra persone di sesso maschile ovvero tra esseri umani ed animali, è punita con la reclusione; può essere emessa anche una sentenza di interdizione dai diritti civili. (ride e canta) Sei andato via da solo, meine
Ottavo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo! Il frate alcolizzato e il boia in attività di Francesca Carlaccini Quest’uomo turba la mia quiete. Ha un sorriso titubante e ingenuo che stride con i suo i gesti netti e il modo in cui si tormenta le mani. Come se le sue mani ruvide e vecchie di duecento anni ancora ricordassero gesti realizzati con maestria e conclusi con raffinatezza. Tutti abbiamo una vocazione in un dato luogo e un dato tempo. La mia ad Apricale è questa: scoprire i segreti di quest’uomo che si fa chiamare Il Boia. L’ho già incontrato un po’ di volte: il luogo e l’ora sono sempre gli stessi. Sei del mattino, al tavolo che guarda verso Perinaldo. Il barista gli porta 2 litri di latte in una caraffa di vetro. Lui, religiosamente rivolto verso il panorama, beve bicchiere dopo bicchiere con una determinazione inquietante, fino a svuotare la caraffa. Risparmia solo le ultime gocce che fanno resistenza e che alla fine del rituale scivolano discretamente sulle pareti trasparenti. Sento di essere in una posizione privilegiata e di poter disturbare le sue abitudini solitarie. Mi siedo al tavolo con lui per osservare da vicino i suoi automatismi fedeli, che mi vengono consegnati con la stessa discrezione, goccia dopo goccia. E cosi goccia dopo goccia, ha confessato di sentire il bisogno del latte e dei paesaggi immobili e pacifici del mattino per contrastare gli incubi notturni. Le sue spalle formano un perfetto angolo retto con il collo e nascondono una tensione muscolare tale da farlo sembrare una macchina da guerra, capace di attutire i colpi di una vita lunghissima. Ma non mi basta, ho bisogno di più informazioni. Devo afferrare l’essenza nascosta di questo sguardo taciturno, le storie sotterrate e ripudiate dalla sua memoria, ma registrate sottobanco dai suoi tessuti muscolari. Perciò l’ho invitato a mangiare al ristorante credendo che un buon pasto e del buon vino gli avrebbero sciolto la lingua. Arriva in tavola lo stinco di maiale locale. Lo vedo frugare nella tasca dei pantaloni e recuperare un coltello. Incide un primo taglio nella carne morta servita nel suo piatto e poi mi porge il coltello perché lo osservi meglio. Il manico di legno sembra molto antico, la lama consumata. Me lo riprende e si rimette a sezionare il porco con chirurgica precisione. Comincia a parlare solo una volta terminata la prima bottiglia di vino, quando le mie gote sono ormai infuocate e io provo un misto tra terrore ed eccitazione. Prima di parlarmi lascia passare un interminabile silenzio. “Se sei veramente un uomo di chiesa, dovresti essere abbastanza colto per sapere cosa rappresentano le incisioni sul coltello.” “Non cercare di ingannarmi: intanto i boia non incidevano le tacche delle loro esecuzioni su un semplice coltellaccio, ma bensì sulla mannaia. E poi non scherziamo, cosa ci farebbe un boia nel 2016?” Il pasto ormai è terminato, nel poco tempo che rimane riesco solo ripetergli frasi fatte sulla bontà degli uomini a cui nemmeno io credo più. Pago il conto e comincio a vagare alla ricerca di un rifugio: mi sento come un bimbo terrorizzato dal buio. Cammino tra scaglie di calcare, ruscelli borbottanti, cortecce antiche, lucertole indolenti, formiche, libellule che tentano di persuadermi dell’equilibrio perfetto del ciclo universale. Ma tutta questa bellezza è illusoria di fronte alla crudeltà umana. Ho bisogno di immergermi in acqua gelida, ho bisogno di sentirmi immobile e in pace per contrastare i miei tormenti. Scendo al torrente, ai piedi di un sentiero che sembra porti lontano, dietro i monti e ancora oltre. Mi siedo su una rudimentale panchina, tentato dall’idea di scomparire dietro i monti come il sentiero. È quando si smarrisce la strada che la Provvidenza ci fa da bussola… È quando si smarrisce la strada che la Provvidenza ci fa da bussola: noto un libro nascosto sotto la panchina. L’autore è una certa Giada Prestanza. Il titolo è Ultime scuse del boia. Comincio a sfogliarlo con ritmo convulso, ogni capitolo è illustrato da un ritratto fotografico in bianco e nero. Lo richiudo e faccio un lungo respiro. Sembra incredibile ma è proprio la storia che stavo cercando. Riapro il libro al prologo e comincio a leggere. È la vita di un ex partigiano e delle sue esecuzioni antifasciste. “Dedico questo libro a chi questo libro me lo ha raccontato: mio nonno Aldo Prestanza.” Scorro le pagine fitte di foto in bianco e nero, datate dal ‘43 al ‘45, alcune anonime, altre eccentriche, altre ancora malinconiche. Durante la Resistenza non tutti erano pronti a sporcarsi le mani, anche se in nome della giustizia. Se nei tempi antichi il boia serviva a far rispettare la legge, per i partigiani della zona il boia serviva a far rispettare la giustizia. Ma la giustizia era illegale. Aldo Prestanza era quindi il mio boia. La mano che aveva sgozzato i ragazzi delle foto era la stessa che aveva stretto la mia. Allora era giovane come loro. Portavano i fascisti su per i monti di Rocchetta Nervina dove già abitavano i fantasmi. Lassù avvenivano le esecuzioni. Per ogni testa, una tacca sul coltello. Richiudo il libro. Se la Provvidenza non ci aiuta a ritrovare la nostra storia, può venirci in soccorso per il bene di qualcun altro.
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. Tempo da cani la giornata di Marianna I cani non hanno tempo e non perdono tempo. Zompano sul letto, guaiscono piano annusando umido e affettuoso; calpestano le lenzuola di lino ricamate da zia Carmela, travolgono i cuscini ergonomici spaziali e mi ammaccano svariati organi interni. Puzzano di macaia, sale e marciume tiepido. Quindi non ho bisogno di aprire le persiane per sapere che fuori c’è un tempo di merda. Non esiste una puzza meno confortante, meteorologicamente parlando. Sbadiglio svogliata, il mastino più grosso mi sta masticando un calzino. Troppo tardi, è già scurito, intriso di bava. So già che nel pacchetto, di biscotti, non ce ne sono per tutti, li lascio a loro, farò colazione al bar. Non ho tempo da perdere. Costa, il mio compagno, occhi verdi, la mia parte psicologicamente sana. Mi osserva come se fossi un unicorno comparso improvvisamente in cucina. Forse dovremmo parlarne “Costa” è il suo cognome, non il suo nome, ma penso che non si debba dare mai troppa confidenza, anche al principe azzurro. Infilo indumenti a caso, denti e deodorante contemporaneamente. I capelli… sono viola, non esiste un modo per sistemare correttamente capelli color addobbo funebre. Mente locale. Michelangelo, il mio bambino, è in bagno che canta a squarciagola Radio Gaga inventando le parole e intanto si lava la faccia con un metodo da lui stesso inventato e brevettato. Riempie (cantando) il lavandino di acqua tiepida e poi , serio come un sufi turco, immerge il muso più e più volte, senza strofinare, senza massaggiare, senza sapone. Fa il sottomarino, riemerge, si asciuga. Passando per il corridoio intuisco attraverso la porta vetrata la sagoma di Federico, il più grande dei miei due figli non miei. Li ho ereditati dalla moglie di Costa che ha preferito disfarsi anche di loro anziché stare li a centellinare. Sta dormendo arrotolato come un fagotto e sta sognando la sua bionda, ne sono sicura. Alessia, la più complicata, ha dormito dalla sua amica Erica, tornerà più tardi. È come se fosse sempre a casa, aleggia nei pensieri di tutti, ha una personalità decisamente ingombrante, usa il mio profumo di nascosto, ma a me non dispiace. La casa è un casino, ma faccio finta di niente. Sono in ritardo. Ora le scarpe e via. Non ho calzini puliti. Io guardo il mastino, lui guarda me. Abbaia. Poi molla la presa.