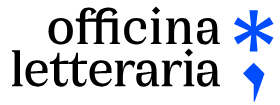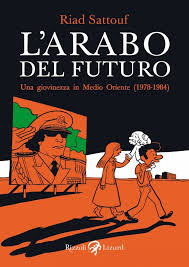Quando ero bambina mia mamma mi ha insegnato a leggere i libri evitando le introduzioni, le prefazioni e qualsiasi ricerca sull’autore: “Sono cose che devi fare quando hai finito la lettura” mi diceva “un testo deve essere letto senza pregiudizi”. Così, complice la mia ignoranza su Jennifer Egan, mi sono avvicinata al suo ultimo lavoro, Manhattan beach (Mondadori, 2018), in modo naif. Ecco la mia impressione. Leggendo “Manhattan beach” di Jennifer Egan di Ilaria Schizzi Le aspettative Approcciarmi al libro in modo disilluso è stato un bene, perché se avessi saputo che si tratta dell’opera di una vincitrice di Premio Pulitzer, avrei avuto forse delle aspettative troppo alte. Il libro è gradevole, molto interessante e davvero ben tratteggiata la sua ambientazione nella New York a cavallo tra la grande crisi e la seconda guerra mondiale, uno dei punti di forza del romanzo. La vita di Anna in un mondo maschilista Un incipit avvincente, narrato dal punto di vista della protagonista, Anna Kerrigan, che conosciamo ancora bambina e di cui seguiremo la crescita mentre cercherà di affermarsi in una società maschilista e discriminatoria. Anna è certamente il personaggio più interessante e meglio delineato del libro, per quanto neanche lei si sottragga a quello che sembra uno dei punti deboli del testo: i personaggi compiono azioni apparentemente non motivate dal loro carattere o dal loro vissuto, ma solo dalle necessità della trama. Così abbiamo un personaggio che lascia New York per trasferirsi in un’altra città, un altro che si allontana dalla famiglia, altri che diventano amanti, senza che se ne comprendano le reali motivazioni. Ho sentito la mancanza dei sentimenti che muovono le azioni di ogni personaggio. Lo stile La narrazione di alto livello si dipana non solo attraverso il punto di vista di Anna, ma anche attraverso quello di suo padre Eddie e di Dexter Styles, un gangster con cui quest’ultimo entra in rapporto di affari. Interessante il punto di vista di diversi personaggi, anche se risultano leggermente piatti. Conclusioni Quindi un libro con scelte stilistiche che possono riscuotere pareri discordanti nei gusti dei lettori. Nel complesso, un romanzo interessante (specialmente nella prima parte), con certi passaggi davvero coinvolgenti. Dall’autrice, mi dico, è lecito aspettarsi qualcosa di più. Aspettiamo curiosi il prossimo romanzo! Voi l’avete letto, che ne pensate?
Antonio Paolacci è uno scrittore che, insieme ad altre cose, è anche docente per i corsi di Officina Letteraria (vedi “I ferri del mestiere” o “Una stanza tutta per sé”). Era da un po’ che non scriveva un romanzo: ci ha provato, ha scritto, ha cestinato migliaia di caratteri, ha riscritto. Poi ha deciso che basta, non avrebbe scritto più niente. Ed è lì che è nato “Piano Americano”, il suo ultimo romanzo-non-romanzo. Ce ne parla Valentina. Piano americano di Antonio Paolacci recensione di Valentina Morelli Matrioska. La bambola più piccola, quella da cui nasce tutto, è un romanzo. Si intitola Piano Americano, è un “libro divertente (…), sorretto da un plot decisamente inverosimile, con tratti di realismo magico e palate di metanarrazione.” Il cuore della bambola più piccola, il cuore del romanzo, è un video, un super8, il cui protagonista, Jakob Goliacci, ha due caratteristiche parecchio bizzarre. La prima: è semi-invisibile, ma non nel senso che è mezzo trasparente e che gli vedi attraverso. Jakob è anonimo al punto che ti dimentichi della sua presenza. Jakob rimane sul limitare della coscienza. Jakob passeggia sul bordo dell’oblio e se ne va, ed è come se non fosse mai venuto. A meno che non lo fotografi, o lo filmi: a quel punto sì che appare, a quel punto sì che entra prepotente nell’occhio di bue della consapevolezza, e quello che vedi ti sconcerta anche di più della sua evanescenza: Jakob è la copia esatta, ma più giovane, di un vecchio imprenditore e politico detto il Nano da giardino, il Puttaniere, il Merda o, anche, Eliogabalo, come l’imperatore romano morto a diciott’anni per abbuffata di perversioni. È Gaetano, il protagonista di Piano Americano, che per caso ferma Jakob sulla pellicola e lo scopre; è Gaetano che, insieme ai suoi amici, inventa un piano per sfruttare la straordinaria somiglianza dando il via a un circo narrativo costruito su situazioni surreali e comiche. Il giorno in cui smetto di scrivere per sempre è una tiepida domenica di metà maggio. Attorno al video di Jakob danzano tutti i personaggi: Gaetano, i suoi amici, i Servizi Segreti, Jakob stesso. A raccogliere il circo, la bambola media della Matrioska, ovvero le vicende di Antonio Paolacci Personaggio, autore del romanzo Piano Americano, che racconta di quando, di come e del perché ha finito con l’arrendersi, col decidere di non scriverlo più quel romanzo surreale e divertente con cui avrebbe voluto “sfondare il muro della narrazione consueta.” Avrebbe dovuto essere il mio lavoro migliore, il più estremo: l’ultima scommessa che mi sarei concesso, l’ultima volta che avrei puntato sulla letteratura. Se fosse andata bene, avrei espresso me stesso con inventiva sfrenata, fregandomene dei vincoli imposti dall’editoria contemporanea, dalle leggi di mercato, dagli ottusi sostenitori della ripetizione. Antonio Paolacci Personaggio, sul punto di diventare padre, si guarda allo specchio – letteralmente e metaforicamente – e decide che non ne vale la pena. La scrittura non mi porta più da nessuna parte, la vita fuori dalle pagine scritte invece sì. Ho pubblicato libri e racconti ed è stato sempre squallido confrontare la fatica del lavoro con il suo valore oggettivo, con il mondo esterno, con l’editoria da prodotto di massa, con il pubblico e la stampa. Stavo viaggiando in direzione dello spreco. Stavo lavorando da anni a un romanzo per niente: anni di lavoro che avrei lanciato ancora una volta nel vuoto pneumatico della comunicazione contemporanea. Attorno ad Antonio Paolacci Personaggio, che racconta del rifiuto da parte di editori e agenti che, pur apprezzando l’intelligenza del suo lavoro, non possono sostenerlo perché di sicuro indigesto per un pubblico abituato a storie ordinarie, c’è la terza bambola della Matrioska, la più grande, quella che avvolge tutto: è Piano Americano, il libro di Antonio Paolacci Autore, che disubbidisce alle regole, che osa, che punta sulla letteratura. La scrittura è per noialtri un’ossessione, un vizio, una condanna, una necessità e un nemico, come il tennis per Agassi. (…) Ogni riga che componiamo è un rovescio a due mani che ci dona stilettate di sofferenza e però continua a tenerci in gioco. (…) Ogni sera andiamo a letto chiedendoci se non dovremmo mollare e addio dolore, ma sappiamo che non lo faremo, che ci sveglieremo sul pavimento anche domattina con la schiena maciullata dalla nostra stessa stramaledetta ostinazione da grulli e torneremo sul campo da gioco, a rispedire dall’altra parte inutili parole all’Avversario, finché il tempo ci consentirà di farlo. Alla fine degli anni Cinquanta, Alfred Hitchcock, già re di Hollywood, decide di girare e produrre Psycho da solo: il film infrange ogni regola e tutti – produttori, critici, amici – sono convinti che non possa funzionare, che Hitchcock si debba attenere a ciò che il pubblico vuole, a ciò cui il pubblico è abituato. Ma Hitchcock sfida Hollywood, rompe gli schemi, va avanti convinto. Antonio Paolacci Autore, come Hitchcock, disubbidisce a chi crede di sapere cosa piace al pubblico, si esprime con inventiva sfrenata, fregandosene dei vincoli imposti dall’editoria contemporanea, dalle leggi di mercato, dagli ottusi sostenitori della ripetizione e scrive un libro tutt’altro che ordinario, un libro che non potrebbe essere più lontano da quanto il pubblico è abituato a leggere. Nel 1960 Psycho ha un successo fragoroso, è il maggior successo commerciale di Hitchcock, e la scena della doccia, simbolo della rottura, diventa la scena più famosa della storia del cinema. Nel momento in cui scrivo, Piano Americano, il libro di Antonio Paolacci a un mese dall’uscita, è già in ristampa.
Fino a una settimana fa non avevo mai sentito parlare di Kent Haruf. Poi sono successe un paio di cose. Il 1 settembre, Robert Redford e Jane Fonda hanno ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia e dopo la premiazione è stato proiettato Our souls at night, tratto dall’ ultimo romanzo di Haruf, di cui sono protagonisti. La cosa non mi ha impressionato più di tanto ma un amico, dopo la mia confessione di ignoranza, mi ha guardato come se fossi una che adotta cani solo per lasciarli sul ciglio dell’autostrada. Allora ho letto Le nostre anime di notte. Un piccolo miracolo. Le nostre anime di notte: ho letto il libro, non so se guarderò il film di Emilia Cesiro La trama Mi chiedevo se ti andrebbe di venire a dormire da me, la notte. E parlare. Addie Moore e Louis Walters sono due vedovi sulla settantina, abitano nella cittadina di Holt, Colorado, a un isolato di distanza. Si conoscono da molti anni, ma non sono mai stati intimi. Una sera di maggio, prima che faccia del tutto buio, Addie va a trovare Louis e gli fa una proposta: andare a dormire da lei la notte, e parlare. Louis le risponde che ci deve pensare. Mentre osserva Addie tornare a casa, Louis raccomanda a se stesso di non essere precipitoso. Il giorno dopo, va dal parrucchiere, si fa sistemare i capelli, si fa radere e poi chiama Addie. Passano la notte insieme. E quella dopo. E poi altre ancora. La storia è questa: due persone che passano la notte insieme, per non stare da soli, sdraiate nello stesso letto, al buio, come buoni amici e si raccontano la vita, perché vogliono sapere tutto. Man mano che la relazione tra Addie e Louis si sviluppa in amore, la narrazione si allarga a comprendere qualche amico, le reazioni della cittadina (piccola, la gente mormora), le vicende dei rispettivi figli, l’arrivo del nipote di Addie, Jamie, una cagnolina abbandonata e poi adottata, e altre cose ancora che non dico perché sennò che lo leggete a fare… In realtà, anche a conoscere la trama, queste 170 pagine andrebbero lette perché, ripeto, sono un piccolo miracolo. Basta poco che un racconto del genere cada nel grottesco o nel melenso, e invece il risultato è delicato, luminoso e dolcissimo grazie a uno stile pulito, semplice, che non perde tempo nelle descrizioni o nell’uso delle virgolette, scivolando dal dialogo alla narrazione come evidenti conseguenze uno dell’altra e rivelando, senza aggettivi, un grande affetto per tutti i suoi personaggi. Non abbiamo fretta, disse lui. No, prendiamoci il tempo che ci serve. L’ultimo libro di Kent Haruf Il tempo è un elemento essenziale del romanzo. Nella Nota del traduttore, Franco Cremonesi (bravissimo) parla del senso di urgenza che pervade il romanzo. Haruf stava morendo mentre scriveva Le nostre anime di notte: si sente la necessità di completare la storia che ha dentro, ed è vero che questa urgenza informa il romanzo e i suoi personaggi. Però le cose hanno una loro naturale evoluzione, anche a settant’anni. Durante una delle prime notti, Louis si fa prendere, nelle sue domande, da una curiosità e una gelosia inopportune. Se ne rende conto e si dà dello stronzo. Addie conferma. Urgenza non significa essere precipitosi o avventati. Nel caso di Addie e Louis, urgenza significa rivendicare pacatamente il diritto a questo amore, alla sua naturale evoluzione e al futuro. Bello, no? Uno scrittore sta morendo e scrive un romanzo sul futuro. Note sparse Kent Haruf (1943-2016) oltre che romanziere, è stato un insegnante, un obiettore di coscienza durante la guerra del Vietnam, un bracciante, un bidello e un docente universitario. Ha pubblicato il suo primo romanzo a 41 anni. Le nostre anime di notte è stato un bel successo editoriale, e il libro più venduto in libreria nella settimana tra il 13 e il 19 febbraio 2017 Gli altri romanzi di Kent Haruf, pubblicati in Italia da NN Editore, sono Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione, che compongono la Trilogia della pianura. In comune hanno l’ambientazione nella cittadina immaginaria di Holt. Una mappa di Holt è allegata sia al cofanetto che raccoglie la Trilogia sia a Le nostre anime di notte. Qui Marco Denti, autore della mappa, spiega come ha fatto. Il film Le nostre anime di notte con Jane Fonda e Robert Redford, diretto da Ritesh Batra, sarà disponibile su Netflix il 29 settembre. Le recensioni vanno dal bellino al proprio bello. Qualcuno l’ha stroncato, qualcuno ha detto che se non fosse per l’aura dorata dei due protagonisti, non se ne sarebbe proprio parlato. Io l’abbonamento a Netflix ce l’ho e lo guarderò, anche se con un filino di preoccupazione, perché quell’atmosfera dolce e luminosa che pervade il romanzo è facile da rovinare. Nel caso, posso sempre rileggermi il libro.
Anche i letterati, ogni tanto, uno sguardo al cinema ce lo buttano. Sempre con quell’aria un po’ snob da “il libro era meglio”, ma ultimamente i titoli tratti da grandi romanzi best-seller sembrano essere sempre di più. Per fortuna, perché si parla di storie valide. Per sfortuna, perché noi lettori sappiamo già come certe storie vadano a finire. È stato proiettato il 4 settembre il nuovo film di Paolo Virzì, “Ella & John”. Sapete che è tratto da un libro? Proprio così, si tratta di “The Leisure Seeker” ed eccomi a farne una specie di recensione. The Leisure Seeker: il libro “The Leisure Seeker” di Michael Zadoorian è stato pubblicato dalla casa editrice Marcos y Marcos nel 2009 nella collana “Gli Alianti”. Dallo stesso autore, la casa editrice pubblicò “Second hand – Una storia d’amore”. La trama è abbastanza semplice: Ella e John sono due ottantenni malati, molto malati. John soffre di Alzheimer, mentre Ella porta dentro un tumore in stadio avanzato. Poi si stufano: i due coniugi si stancano di passare la loro vita tra pillole, pasticche e cicli di chemioterapia, e partono. Prendono il loro vecchio camper e imboccano la Route 66 da Detroit, diretti a Disneyland. Ci andavano spesso a Disneyland, con i bambini quando erano piccoli. Ella pensa che sarebbe bello tornarci almeno una volta, in quel parco di divertimenti, prima di morire. Già. Non ci sono mezzi termini, altri modi per dirlo: Ella e John stanno morendo, e lo sanno, e lo sappiamo anche noi che leggiamo fin dalla prima pagina. Questa consapevolezza rende la lettura del romanzo un mix tra “tanto so come va a finire” e “speriamo però che non succeda”. Non vi dico come va a finire, ma in entrambe le alternative c’è la certezza dei lacrimoni. La scrittura di Zadoorian è limpida, schietta, semplicissima. Forse, per mio gusto personale, a tratti troppo semplice, la punteggiatura ridotta all’osso; bene, però, perché insieme a due dolci vecchietti che attraversano l’America in camper, le figure retoriche sarebbero state decisamente troppo stucchevoli. Ad ogni cittadina che il camper di John attraversa, un nuovo capitolo, un nuovo spaccato della stra-vista vita on the road americana: diner, motel, attrazioni turistiche scadenti, hamburger. Soprattutto hamburger. Questo viaggio serve principalmente ad una cosa, cioè a porre una domanda al lettore. E la domanda è sempre quella: perché continuare a vivere malati, se si può morire bene? L’eterno dilemma del “non rianimatemi”, delle cure palliative, delle malattie mentali. Vi dirò che è difficile rispondere, neanche Zadoorian ci riesce secondo me, ma la domanda la pone molto bene. È bello, così, è bello tacere. Parlare rovinerebbe tutto. Per un attimo, potrei piangere dalla felicità. È per momenti come questo che amo tanto viaggiare, la ragione per cui ho sfidato tutti. Noi due insieme, come siamo sempre stati, senza parlare, senza fare niente di speciale, semplicemente in vacanza. Lo so che niente dura, ma anche quando ti rendi conto che qualcosa sta per finire, puoi sempre voltarti indietro e prendertene ancora un po’ senza che nessuno se ne accorga. In viaggio contromano: il dilemma del titolo Ho avuto il piacere di sentire Claudia Tarolo, editore di Marcos y Marcos, raccontare la genesi di questo romanzo. Qualche tempo dopo la pubblicazione di “Second hand”, alla Marcos y Marcos si chiedevano che fine avesse fatto il buon vecchio Michael Zadoorian. Lo hanno contattato loro, chiedendogli se aveva qualche nuovo romanzo nel cassetto. Michael ha risposta affermativamente, inviando in casa editrice “The Leisure Seeker”. Il manoscritto è capitato tra le sue mani in lingua originale, Claudia l’ha letto in un giorno e una notte, e subito ha capito che quel romanzo andava pubblicato. Se ne è innamorata a tal punto, che ha deciso di tradurlo lei stessa. Peccato per il titolo: “The Leisure Seeker”, un gioco di parole intraducibile, dove in inglese Leisure Seeker indica un noto modello di camper, ma soprattutto significa anche “il cercatore di divertimento”. Tagliando la testa al toro, si è lasciato il titolo originale, con l’aggiunta di un sottotitolo: “In viaggio contromano”. Perché cos’è il viaggio di questi due simpatici vecchietti, se non una corsa contro il tempo? Tutti gli chiedono di stare a casa, di curarsi, ma Ella e John vanno in direzione opposta, non verso la morte, ma verso la vita. Ripenso all’accappatoio rosso che avevo a ventisette anni, al suono delle zampine del nostro primo gatto Charlie sul linoleum della vecchia casa; all’aria arroventata intorno alla pentola di alluminio un attimo prima che i chicchi di grano diventassero popcorn. Rievoco questi particolari con la stessa frequenza con cui rievoco il giorno del mio matrimonio, la nascita dei miei figli o la fine della Seconda guerra mondiale. Il fatto davvero impressionante è che prima che tu te ne renda conto sono passati sessant’anni e hai in mente otto o nove eventi capitali accanto a migliaia di eventi assolutamente insignificanti. Come può essere? “Ella e John”: il film di Paolo Virzì Sempre Claudia Tarolo fu contattata un giorno da Paolo Virzì, lui le chiese “Se dovessi consigliarmi un libro da cui trarre un film, quale mi consiglieresti?”. La risposta è la pellicola che avremo modo di gustare nei nostri cinema dal 25 gennaio 2018. Intanto, c’è chi ha avuto modo di vederlo. Vi consiglio pertanto questa breve impressione di Sara Boero (sì, quella che insegna anche a Officina Letteraria), inviata di The MacGuffin che ha avuto modo di vedere la proiezione in anteprima e con il posto riservato. “John. Mi ami?” Strabuzza gli occhi. “Ma che domanda è? Certo che ti amo”. Viene più vicino a mi bacia. Sento il suo odore. Non sa proprio di buono, ma è pur sempre l’odore di mio marito. “Lo so”, gli spiego. “Volevo sentirmelo dire da te. Non me lo dici più molto spesso”. “Me lo dimentico, Ella”. “Lo so, John”. Porto l’altra mano sul suo visto. Bacio mio marito. Lo stringo a me e non aggiungo altro. Passano i minuti, e la notte sospesa si riprende i suoi occhi. È ora di alzarsi.
Il Far West non è una vecchia storia con cavalli, cowboy, sparatorie dentro i saloon e bicchieri di whisky. Il West esiste ancora, il Texas c’è ancora, e dentro al Texas e le sue strade polverose può capitare di trovarci ancora qualche sceriffo oscuro a caccia di vendetta. Basta seguire le orme degli pneumatici, le impronte degli stivali, le scie di bossoli, ci vuole poco per caderci dentro con due piedi, come nello sterco… “Nel dolore” di Alessandro Zannoni Certo: i cowboy non viaggiano più per il paese in groppa ai loro destrieri, ma usano pickup scassati; le pistole però sono cambiate poco, e fanno sempre molto male. Questi sono i presupposti d Nel dolore (A&B editrice) di Alessandro Zannoni, autore nato a residente a Sarzana, con diverse pubblicazioni alle spalle. Nel dolore è il secondo romanzo che ha come protagonista Nick Corey, un italo-americano immigrato in Texas, figlio di una madre che parla una lingua mischiata tra inglese, italiano, il messicano e quella dei nativi. La prima volta Nick Corey è apparso nel 2011 in Le cose di cui sono capace, uscito con Perdisa Editore. La gestione della collana era già in mano a Antonio Paolacci (tra le altre cose, maestro di Officina Letteraria), erede naturale di Luigi Bernardi, e Antonio ne curò anche l’editing. «E con Stella come va». Alzo gli occhi dal piatto e la guardo serio. «Bene, ma’. Le cose vanno bene». «Cercherai anche stavolta di sposarla, io credo». «Credo che sì, quella è l’idea. Ma stavolta me lo ha chiesto lei», dico facendole un mezzo sorriso vincente. «Quindi sei tu quello che scapperà con i motociclisti», dice senza ridere. Nick Corey è sceriffo di BekereedgePass, è fidanzato con Stella, ragazza che è tornata da lui dopo averlo abbandonato all’altare e lasciato solo per sette anni, e ha un problema con l’alcol. Di recente, qualcuno ha ammazzato il suo unico e migliore amico Rudy. Quindi Nick ha anche una missione: trovare chi ha ucciso Rudy, e fare giustizia. A modo suo. Il romanzo è narrato in prima persona, da Nick, e il linguaggio è quello che ci si aspetta da lui: duro, amaro, masticato più volte come una foglia di tabacco. Dritto come la trama, un proiettile verso la fine; una brutta fine. «Pensi che finirà male, Nick?» «Credo proprio non ci sia alternativa, Stella». Ad alcuni, il nome di Nick Corey potrebbe suonare familiare. C’è un motivo, e ve lo spiega l’autore stesso, a cui abbiamo fatto alcune domande. OL: Come è nata l’idea di ambientare il romanzo nel Texas, e l’idea di utilizzare un protagonista italo-americano? Alessandro: È un’idea nata da una provocazione che avevo fatto a Luigi Bernardi su Facebook: si possono fare cover di canzoni arcinote, si possono fare remake di film straconosciuti, ma a nessuno verrebbe in mente di riscrivere un libro famoso perché verrebbe subito accusato di plagio. Bernardi venne fuori con questa proposta: avrebbe pubblicato chi si fosse cimentato a riscrivere un classico. Ci ho pensato un po’ su e mi sono reso conto che il mio classico per eccellenza, parlando di noir, è un libro scritto nel 1961, ma che ha una freschezza che sembra uscito dalla tipografia un’ora fa: Colpo di spugna di Jim Thompson. Del romanzo originale ho mantenuto l’ambientazione americana per svariati motivi, il più importante dei quali è che volevo poter giocare ad armi pari con gli autori d’oltreoceano – partono avvantaggiati, nell’inventare una storia, perché in America tutto è possibile e i lettori italiani accettano questo assioma senza storcere la bocca, cosa che non accade nelle trame ambientate in Italia, dove ti fanno le pulci su qualsiasi cosa -. L’idea di utilizzare un protagonista italo-americano è derivata dalla mia voglia di giustificare l’uso del nome di Nick Corey. Mi pareva davvero irrispettoso usare a cuor leggero un personaggio così iconico e riconoscibile, quindi mi sono immaginato che questo nome fosse in realtà davvero casuale, nato dalla traduzione dell’italianissimo Nicola Coretti, figlio di immigrati naturalizzati americani. E questa cosa la spiego perfettamente nel primo romanzo con protagonista Nick Corey. Il mistero della vita è che non c’è nessun mistero. Nasci vivi muori. Stop. OL: Come ti sei documentato su questi luoghi? Sono reali o di fantasia? Alessandro: Siamo esterofili, che ci piaccia o no, e l’America ci ha plagiato ben bene. Perciò credo proprio che ogni italiano di mezz’età abbia un ottimo background americano, grazie a libri, film e documentari, e con tutte queste informazioni non è servito andare in Texas di persona per ricreare una realtà plausibile e credibile. Ho scelto un luogo ideale dove immaginare la città di BakereedgePass, ho studiato alcune cittadine reali che sorgono in quella zona tramite Google Maps, e poi tutto mi è venuto naturale, tanto che nessun lettore si è lamentato. Anzi. E ad alcuni di quelli che mi hanno chiesto se ho vissuto in quelle zone, ho risposto di sì, per i primi quindici anni della mia vita, per non deluderli. In effetti credo di aver fatto un buon lavoro. L’amore e la vita sono una merda necessaria. OL: Perché “nel dolore”? Perché “l’amore e la vita sono una merda necessaria”? Alessandro: Per Nick il dolore è la condizione umana naturale. Lo ha messo alla prova, violento e inarrestabile, fin da quando era indifeso e innocente. Ha forgiato il suo carattere, inciso sulla sua vita. Nick non ha paura di affrontarlo, ci si butta a capofitto, perché sa che solo attraversandolo può raggiungere la sua pace. “La vita è una merda necessaria”, dice Nick, perché non può fare a meno di viverla, gliel’hanno data e non può tirarsi indietro, anche se ogni volta che si sbronza cerca di ammazzarsi ficcandosi la pistola in bocca. Sarebbe la via più breve per smettere di soffrire, ma c’è sempre un buon amico che lo aiuta a desistere, e un motivo forte per non farlo. Il motivo è l’amore, quello che prova per Stella, che crede sia la sua redenzione per diventare un uomo migliore e vivere una vita diversa e felice. In fin dei conti,
È tempo di Natale. Tempo di un libro davanti al caminetto mentre fuori nevica. Un periodo nordico, come nordico è il libro di cui vogliamo parlare oggi. Si tratta di Joe Speedboat di Tommy Wieringa, Iperborea edizioni. Questione di pelle: “Joe Speedboat” di Tommy Wieringa, Iperborea edizioni 2009 vs 2015. La casa editrice Iperborea nasce nel 1987, con l’intento di fare conoscere ai lettori europei la letteratura nordica. A Emilia Lodigiani, fondatrice di Iperborea, è apparso chiaro che i suoi libri dovessero distinguersi dal mare editoriale in cui navigavano. La scelta, quindi, fu quella di dare ai libri Iperborea una particolare connotazione fisica, che li avrebbe subito resi differenti, o meglio: una novità. Stiamo parlando del caratteristico formato super-verticale. Come un mattone di cotto. Strettissimo e lungo, 10×20 cm, ispirandosi al formato tradizionale del mattone di cotto. Una sorta di misura modulare ed elementare, che rappresenta l’unità prima sulla quale si è – in un certo senso – costruita tutta la nostra civiltà. A prima vista, può capitare di pensare che questa forma longilinea possa risultare scomoda al lettore: ma si aprirà? Come faccio a sfogliare le pagine? Devo inclinare la testa ogni volta che arrivo a fine riga? Accadeva in minima parte con la vecchia impostazione di Iperborea. Per esempio, la prima edizione di Joe Speedboat (2009) può risultare un po’ difficile da maneggiare. Stiamo parlando di un volume importante, più di 300 pagine, che diventa di difficile consultazione, specialmente dopo la metà del libro; le pagine finali tendono a sfuggire dalle mani, il libro rimane difficilmente aperto e, in effetti, bisogna leggerlo quasi come un manga: senza aprirlo del tutto e assumendo con la testa l’angolazione migliore per leggere fino all’ultima lettera della riga. Il restyling del 2015. Problema che, di certo, non si riscontra con la nuova edizione di Joe Speedboat, del 2015, anno in cui Iperborea ha rinnovato grafica e materiali raggiungendo un netto miglioramento estetico e funzionale. I progettisti di Studio Xxy, firma del progetto di restyling grafico, si sono dedicati con particolare attenzione alla scelta della carta. Divertendosi a sezionarea metà un volume Einaudi, fino a ridurlo alle stesse proporzioni di un Iperborea, hanno appurato che il moncherino rimanente non era comodamente sfogliabile. Il problema tecnico non era dato tanto dal formato, bensì dallo spessore della carta. In sostanza, la grammatura comunemente usata per i volumi di formati “standard” non è adatta al formato di Iperborea. Studio Xxy si è, quindi, per una carta Imitlin di Fedrigoni, una carta pregiata, ma, allo stesso tempo, ruvida, che sa di tela d’artista, trasformando ogni libro Iperborea in una piccola opera d’arte. Inoltre, la nuova carta è più morbida, permettendo di “squartare” (come dice la stessa casa editrice) il libro, aprendolo più facilmente e leggendo con più gusto. Il formato super-verticale non è solo potenziali difetti. Anzi! La gabbia allungata rende più rilassante la lettura, che va a capo più volte; inoltre, i libri stretti sono facilissimi da tenere con una mano, per gli amanti delle letture “on the road”. Il formato di Iperborea si odia o si ama, ma, a mio avviso, dopo il restyling è molto più facile amarlo. “Joe Speedboat” di Tommy Wieringa. Finalmente parliamo di Joe Speedboat. Ve lo dico subito: un libro meraviglioso. Oserei dire uno dei miei romanzi preferiti. Per chi ama le epopee, le grandi avventure, i romanzi di formazione alla Stevenson, il libro dello scrittore olandese non deluderà le vostre aspettative. Un accenno alla trama. Molto brevemente: Fransje è un ragazzo che, dopo un incidente, si ritrova bloccato su una sedia a rotelle, che può spostare grazie al suo braccio destro, l’unico arto ancora mobile. Nel paese di Fransje si trasferisce un misterioso e affascinante ragazzo che si fa chiamare con un soprannome: Joe Speedboat, appunto. I due fanno subito coppia, e si perdono in strabilianti avventure. Non vi anticipo nulla, ma di mezzo c’è anche un campionato di braccio di ferro. Straordinario. Cambio di titolo, cambio di immagine. Possiamo notare che dalla prima alla seconda edizione per conto di Iperborea, oltre all’immagine, cambia anche il titolo. Da semplicemente Joe Speedboat, si passa a Le avventure di Joe Speedboat (raccontate da un campione di braccio di ferro). Ma dicevamo, soprattutto cambia l’immagine (oltre alla grafica, di cui parleremo nel capitolo successivo). Benché la figura del bambino sull’aeroplano della prima edizione sia forse più rappresentativa del libro (per chi leggerà), la nuova immagine spicca per i suoi colori armoniosi. Iperborea ha infatti sempre manifestato grande gusto cromatico nelle sue copertine. Se le mettessimo tutte in fila e le guardassimo da lontano, sembrerebbero piccoli pixel color pastello, freddi, algidi, ma al contempo accoglienti; formerebbero un grande quadro paesaggistico, riassumibile con le parole “Grande Nord”. La grafica. Fin dalle prime edizioni, le copertine di Iperborea hanno dimostrato originalità con le immagini a vivo, che in quel tempo ancora nessun editore applicava. Dal 2015, le immagini delle copertine si estendono, fino a girare intorno a tutto il libro, andando a occupare anche i (nuovi) risvolti che impreziosiscono l’edizione. Cambia la collocazione del titolo del libro, che ora si trova su un fondo a tinta unita, generalmente in armonioso abbinamento con i colori dominanti dell’immagine di copertina. Scelta apprezzabile, che rende più leggibile i caratteri, rispetto alla vecchia scelta di testo bianco direttamente sovrapposto all’immagine. Il font. Anche il font di Iperborea ha subito una trasformazione dopo il restyling del 2015. Prima era un graziato, del tutto simile a un Garamond allungato (e come poteva non esserlo?) in verticale. Adesso (anche se la nuova edizione di Joe Speedboat conserva ancora il vecchio font) si è passati a un bastone, sempre maiuscolo: più massiccio, più leggibile, forse più attuale. Lo possiamo vedere nella copertina de Il re dell’uvetta di Fredrik Sjöberg (2016, P.S.: divertentissimo libro anche questo!). Il logo. Per finire, è stato cambiato il logo stesso della casa editrice. Prima era una runa che sormontava il nome della casa editrice. La runa si è evoluta, abbandonando il testo scritto, passando da segno a simbolo. Autosufficiente. In breve: Font: 8 Immagine: 7 Titolo: 8.5 Complessivo: 7.8
Per la serie di post Questione di pelle, analizziamo la copertina dell’ultima fatica di Don DeLillo: Zero K, pubblicato da Einaudi nella collona dei “Supercoralli”. Questione di pelle: “Zero K” di Don DeLillo, Einaudi, 2016. Bisogna dire che qualunque titolo – anche il decimo pezzo della saga di Twilight – sembra subito un classico, se a pubblicarlo è Einaudi. Gli ingredienti sono pochi, semplici e immortali: il bianco di sfondo, un’immagine centrata, una scritta asciutta. Che la copertina sia rigida o morbida, i libri Einaudi sembrano sempre pronti per entrare nello scaffale di una biblioteca e restarci per sempre. E spesso lo fanno. L’ultima perla di Don DeLillo è certamente ben inquadrata all’interno della collana Einaudi. Pochi altri editori avrebbe potuto restituire a uno dei più grandi scrittori americani viventi una veste degna del suo Zero K; un libro che porta con sé gli ingredienti che lo consacrano già a classico per licei: distopia, futuro ma non troppo, grandi temi come l’immortalità e le nuove tecnologie, senso metaforico, frasi ispirate. I Supercoralli Einaudi. Zero K abita la collana dei “Supercoralli” di Einaudi, istituita da Cesare Pavese poco prima degli anni ’50. “Supercorallo” vuol dire un punto fermo della letteratura (che sia italiana o estera), in genere ancora più fermo di un semplice “Corallo”. Possiamo dire che il titolo si prepara quasi certamente a entrare nei “Millenni”. I “Supercoralli” hanno principalmente tre opzioni di veste grafica: La classica impostazione bianca con immagine centrata (quella che analizzeremo a breve); Un’immagine espansa a piena pagina (con foto al sangue), che funge da sfondo al titolo e autore. Talvolta, come in questo caso de L’uomo che cade, titolo e autore lasciano la loro posizione alta e centrata, a favore dell’immagine di sfondo; L’immagine come banda passante su sfondo bianco, un’interpretazione più attuale della classica gabbia centrata che possiamo vedere appliacta in Candore di Mario Desiati (2016). I font Einaudi. Parliamo due secondi del font Einaudi. Senza addentrarci nel dibattito del font utilizzato per i testi interni (anche se pare definitivamente che sia un Simoncini Garamond, anche detto Einaudi Garamond), osserviamo com’è scritto il titolo in copertina: Il font di copertina appare come un Helvetica Neue Bold, leggermente tirato in orizzontale. Per i fan della bianca, un font poco graziato potrebbe stonare con lo stile Einaudi. Se devo dirlo, analizzando il font a sé stante, non lo trovo squisito nemmeno io: le lettere sono larghe, stretchate in orizzontale. Ma riconosco all’Helvetica l’imponenza necessaria a dare peso a un titolo. La distinzione tra titolo del libro e nome dell’autore viene resa palese ai minimi termini. Einaudi cambia giusto il colore (nero / rosso). Stessi punti tipografici, allineamento a lapide. Ringraziamo comunque dell’accorgimento, perché nei primi “Supercoralli” non era concesso neanche il cambio di colore, lasciando spazio a possibili ambiguazioni. Immagine e Immortalità. La scelta del soggetto per l’immagine di copertina è a dir poco azzeccata: è intitolata Sime ed è opera del fotografo Jasper James. Lo scatto della statua vuole farci capire subito e bene il tema del libro: l’immortalità. E cosa meglio di una statua classica – fredda e pietrificata – può farci immaginare cosa voglia dire uno stato di criogenesi, il congelamento necessario per arrivare nel futuro, oltre il proprio tempo? L’impaginazione grafica. Proviamo a entrare nel merito dell’impaginazione con qualche speculazione. Sappiamo che è facile avere una copertina bianca e un’immagine potente; meno facile è sapere come collocare l’immagine all’interno del vuoto. Si può notare una cosa interessante. L’area rossa indica la sezione aurea della copertina, ottenuta riportando la dimensione della base sull’altezza. Salta all’occhio che il naso del viso cade proprio sulla linea di demarcazione del quadrato rosso: si trova quindi in sezione aurea con la dimensione totale della copertina. Otteniamo di conseguenza che la linea del naso divide perfettamente a metà la copertina, e la linea orizzontale degli occhi fornisce l’ascissa del nostro sistema. Nonostante il volto di pietra non sia visibile nella sua interezza, esso è collocato in modo da costituire il centro focale della copertina. Saranno pure speculazioni. Però anche nelle riconosciute proporzioni del volto, la radice del naso si trova in sezione aurea con l’altezza del volto: tracciando un cerchio che ha come diametro la larghezza del volto, la radice del naso si trova sulla circonferenza del cerchio, esattamente nel centro di esso. In conclusione. Il volto di pietra di Zero K è perfettamente proporzionato con se stesso e con la sua copertina. Volute o casuali, queste coincidenze geometriche donano un grande senso di pace; una fermezza, una quiete degna di un grande classico. Nonostante sia stato appena pubblicatob (e noi siamo andati ad ascoltarlo al Ducale). “Zero K” è un libro sulla percezione. DeLillo riesce a far parlare i morti (in 1ª e in 3ª persona, contemporaneamente). #ZeroK #DonDeLillo — Officina Letteraria (@OfficinaLettera) 26 ottobre 2016 In breve: Font: 7 Immagine: 9.5 Titolo: 10 Complessivo: 8.5
Vi siete mai avvicinati a un autore sconosciuto, solo perché il suo libro aveva una bella copertina? Avete mai comprato un libro perché sarebbe stato proprio bene tra i vostri scaffali? Accarezzate i libri, mentre li leggete? Scegliete un ebook perché la copertina vi ha ammiccato dallo store? Perché una buona copertina? Da sempre la confezione di un libro – dalla copertina, passando per la carta, il formato, i colori, i font – influisce in modo significativo sulla promozione del titolo e sul successo di un titolo. Ogni casa editrice cerca di sviluppare un proprio linguaggio estetico; in questo modo, i libri della casa editrice sono più riconoscibili. Tramite una buona copertina è possibile comunicare al lettore di cosa tratta il volume in questione, ma non solo. È una comunicazione visiva, che prescinde dal linguaggio verbale, ma che si esprime attraverso forme e colori. Insomma, è una questione di pelle! In questa rubrica, proveremo a “smontare” la copertina di un libro, cercando di capire le dinamiche grafiche e – di sponda – editoriali che hanno portato a quel risultato. O semplicemente, spiegheremo perché quella determinata pelle è adatta al contenuto o perché, secondo noi, non funziona. Gli articoli. Il primo appuntamento è con Don DeLillo e il suo Zero K (Einaudi editore, 2016).
Anche il dolore – come la vita – non si può mettere in ordine alfabetico. Il dolore è un disegno senza colore, è un cibo senza sapore, è una consolazione, una difesa. Ci sono dolori che non fanno male a nessuno e altri che possono anche ammazzare. Ci sono dolori che si possono lasciare a casa quando usciamo e dolori che sono sempre con noi, ci seguono dappertutto. Ci sono dolori da chiudere a chiave e dolori da prendere in braccio. Ci sono dolori che qualcuno ci lascia e dolori che lasciamo a qualcuno. Un bene al mondo, l’ultimo libro di Andrea Bajani per Einaudi, comincia con il “C’era una volta…” delle favole per bambini anche se non è una storia per bambini. Il protagonista è un bambino, un bambino come tanti altri, come quello che siamo stati o che ci circola per casa; un bambino senza nome proprio perché è un bambino come ce ne sono tanti. Il bambino ha un dolore per amico che lo accompagna a scuola, nei boschi, lo consola e lo difende. Stare vicini al dolore di un bambino è la prova più difficile che possa capitare agli adulti. Andrea Bajani ci chiede di farlo, di essere vicini al dolore del bambino però ci accompagna, ci tiene per mano perché sa che certi territori sono difficili da attraversare e che è possibile solo se qualcuno ci tiene per mano. Entriamo in una casa e in un paese, osserviamo gli adulti con le loro miserie e le loro fragilità, osserviamo i bambini con la loro crudeltà e la loro innocenza, incontriamo la bambina sottile che lascia il dolore a casa, si lega i capelli sulla nuca e affronta con coraggio le situazioni. Sperimentiamo i confini, quelli della casa e del paese e i confini dello spazio nel quale si muove il dolore. Con il bambino cerchiamo di passare inosservati, di essere bravi, proviamo a scappare e a nasconderci, con il bambino sperimentiamo il vuoto, il silenzio che a volte è un posto sicuro. Con il bambino entriamo in un mondo in cui è più facile che siano i bambini a proteggere gli adulti piuttosto che il contrario. Con il bambino viviamo una emozionante storia d’amore che ci tiene con il fiato sospeso fino alla fine. Il racconto di Bajani chiede molto al lettore, gli chiede di sostenere una grande tensione, gli chiede di percepire quasi fisicamente la fatica che il bambino fa per mantenere un equilibrio, perché le cose non si rompano. Ma poi, c’è sempre un momento in cui qualcosa cede e quasi tutto va in frantumi. La fine è un nuovo inizio, non meno difficile ma ricco di possibilità. Le cose che si aprono e le cose che si chiudono fanno sempre un rumore caratteristico, quando si aprono e quando si chiudono. Il bambino lo sa e a un certo punto decide di raccontarlo, di usare le parole per descrivere il rumore che fanno le cose quando si aprono e quando si chiudono. E tutto cambia.
Sei sempre stato qui: recensione del romanzo di Eugenio Gardella, primo esordiente di Officina Letteraria, edito da Frassinelli
Quando ho preso per la prima volta in mano L’Arca le mie dita infreddolite si sono posate sulla copertina di carta opaca e dalla consistenza spessa e hanno cominciato a fare su e giù, incapaci di smettere, come tirate da una forza di piccoli fili invisibili, lungo e dentro l’azzurro che dalla superficie del libro promana. Credo fosse il modo di riconoscere qualcosa che si stava aspettando da un po’. Inutile fingere, ho letto il primo romanzo di Ester Armanino esattamente cinque anni fa, quasi in questo periodo, inutile fingere che non sia stato uno dei libri che più ho desiderato che ognuna delle persone che ci teneva a sapere qualcosa di me leggesse. Ai tempi non la conoscevo, se non tramite la familiarità che sentivo per Bianca, la sua protagonista, quel pezzo autentico di lei finito tra le pagine. E poi quella scrittura, quella scrittura così delicata e chirurgica allo stesso tempo, quella scrittura che non risparmiava niente, nessun dettaglio, nessuna emozione: sentivo vicina anche lei. Diceva le cose come si dovevano dire. Come capita quando incontri il libro e lo scrittore giusti al momento giusto. Una volta un ragazzo con cui uscivo, dopo aver letto il libro su mio suggerimento, con aria seria mi aveva allungato una domanda che non mi sono dimenticata: ma come fa a raccontare così lucidamente quei particolari dell’infanzia che quasi tutti si dimenticano? I casi sono due, si era risposto: o ha una macchina del tempo oppure è davvero brava. Sono abbastanza sicura che Ester Armanino non viaggi sulle macchine del tempo, anche se, forse, le piacerebbe. Comunque sì, la considerazione rimane la stessa, anche dopo aver letto L’Arca: non ha perso il dono, gli occhi del “bambino”. Questa volta li infila nello sguardo luminoso di Pietro, figlio di Nadia, sei anni, cucciolo dalla personalità acuta. È lui che, tirando il cordino della storia, ci porta a bordo dell’arca. Accanto e vicino ai suoi genitori, a sua zia, ai suoi cugini, al cane Barba e a un amico speciale. Pagina dopo pagina, ci presta i suoi occhi, che sanno ancora credere ai draghi e ci fa entrare dentro a una metafora che, con la potenza del simbolo, ha la capacità di rendere tutto più chiaro. Parlavo dell’azzurro della bellissima copertina, illustrata da Cecilia Campironi. Sì, le mie dita si sono tuffate, assetate, in quell’azzurro, perché in questo libro la pioggia è il più importante dei quattro elementi. L’acqua. L’acqua che scorre e minaccia. L’acqua che arriva violenta e lascia senza via di scampo. L’acqua di Genova, a volte, e di tutti quei posti in cui si è imparato a temerla. Ma la temevano già gli antichi ed è proprio così che il libro comincia: con Noè e la grande imbarcazione. Ma non è del tutto corretto, perché il libro comincia, a dir la verità, con la moglie di Noè, che, rannicchiata come una cimice nella barba del suo importante uomo, vuole raccontare per noi una prospettiva inconsueta di quella stessa storia che tutti, più o meno, conosciamo: ci tiene a dire perché anche lei è lì. La storia:“Io, hai detto sollevando le spalle. Come sono?” Teresa e Nadia. Due sorelle. La norma e la trasgressione. Sventatezza e Avvedutezza, come le chiamavano da piccole. Due poli al cui interno si cela anche l’opposto. Divise per anni dalla paura del giudizio dell’altra. “Volevo essere come te” E Pietro, figlio di Nadia, che “vorrebbe essere nell’arca” perché “vuole stare dove succedono le cose, anche quelle che non capisce”. Teresa, che non lascia affondare la nave, non la lascerà. Nadia, che ora ha bisogno di lei. E poi il significato della malattia “La radiazione elettromagnetica attraversa le sue diverse strutture anatomiche, quelle più dense e quelle meno dense, viene captata da piccole camere di ionizzazione, poi diventa un segnale elettrico, è elaborata dagli algoritmi, fornisce un’immagine. È quella la donna che sta cercando.” Una storia sull’identità. E sulle differenze. E su cosa vuol dire crescere sempre davanti alla propria ombra, come la intendeva Jung: il proprio opposto. “Ma non ho più paura a esserti compagna nella tempesta… Sorella, non negarmi il privilegio di morire insieme a te… Che vita sarà la mia, quando non ci sarai più?… In parti uguali è divisa la colpa.” (Antigone, tradotto da Ester Armanino e Maria Rosaria Di Garbo) Nel libro compaiono alcuni versi, tradotti personalmente dal greco antico all’italiano dalla nostra autrice, della tragedia di Sofocle, Antigone. Antigone ed Ismene, sono due sorelle che aiuteranno le due sorelle, Nadia e Teresa, a mettere a confronto le loro personali posizioni, i loro personali equilibri nella storia. Due cuori speculari. L’ordine e la rivoluzione. E allora che cosa sarebbe Teresa senza Nadia? E cosa Nadia senza Teresa? Sono state libere di scegliere i loro ruoli e i loro “difetti tragici” oppure si sono determinate vicendevolmente al contrario? Chi ha scelto meglio? Chi ha fatto meglio? Chi si merita di restare? Chi decide di andare? Chi di salvarsi? “Quale sarà la mia felicità? Che donna felice diventerà la piccola Antigone? Quali miserie bisognerà che compia anche lei, giorno per giorno, per strappare coi suoi denti il suo piccolo brandello di felicità? Ditemi, a chi dovrà mentire, a chi sorridere, a chi vendersi? Chi dovrà lasciare morire voltando lo sguardo?” (Antigone, di Jean Anouilh) L’Arca di Ester Armanino racconta, ancora una volta, del dolore e della separazione, della meraviglia e dell’intensità di ogni piccola scheggia di quotidiana realtà come di qualcosa di vitale importanza. Auguro anche a voi di poter sentire nella sua scrittura tutta la dedizione e la scelta fine e accurata che, cinque anni fa come oggi, ho percepito nelle sue parole. Una volta, poco tempo fa, mi ha detto che a volte si chiede che cosa pensino le sue parole di lei: lei che le sposta, le cambia, le aggiunge, le accorcia, le unisce, le lima, le taglia… all’infinito. Si sentiranno maltrattate forse, sottoposte a torture turche! Io, che sono qui a leggerne la composizione finale, credo che si sentano felici di stare dove lei le ha messe.
La nostra recensione di Volevamo essere Jo, romanzo di Emilia Marasco in uscita per Mondadori il 29 aprile 2016
Si dice che i giovani d’oggi sono quello che sono per colpa di qualcuno, o di qualcosa. Di chi, esattamente? È forse colpa dei genitori, dei nonni, della società, dei reality show, del cellulare regalato troppo presto, delle maestre che si fanno dare del tu? Difficile rispondere. Cambiamo domanda. Esiste davvero una colpa? Ogni età ha i suoi malanni. Il malanno di Bianca è tipico di buona parte degli adolescenti: credere che ogni cosa che avviene sia irrimediabile. Bianca vuole fare l’attrice, e l’articolo non è scelto a caso: non vuole essere un’attrice, vuole essere l’attrice, la stella più luminosa di tutte, che così luminosa non ce n’è mai stata. Bianca crede che se non realizzerà ora questo sogno, ora, nei suoi acerbi sedici anni, la sconfitta sarà irrimediabile, non lo realizzerà mai. Perché non esiste un dopo, per gli adolescenti, la vita è un oggi senza fine, e oggi è suo fratello Valerio la stella del cielo di famiglia, Valerio e le sue scarpe da calcio, Valerio e le sue battute affilate, Valerio che mamma e papà hanno occhi solo per lui. «Anche mamma e papà mi guarderebbero con la stessa passione, ne sono certa. Se solo Valerio smettesse di esistere». Bianca cerca allora approvazione in tutti gli altri occhi del mondo, specchi in cui riflettere la sua immagine di diva, la sola che comprende. Bianca recita così bene che tutti le credono: a Gabriele, il nuovo arrivato, non sembra vero che lei, così bella, scelga proprio lui per farlo la prima volta, scelga proprio lui come alleato per avvicinarsi al suo irrimediabile sogno. Bianca recita così bene che ormai, di se stessa, conosce solo la messa in scena. Ogni emozione, in lei, è irrimediabilmente frantumata: non c’è dolore, né rabbia, né felicità, né spensieratezza. Il provino all’Accademia d’Arte Drammatica e la premeditazione di un assassinio sono recitate con la stessa intensità. Ha un solo amore, Bianca. Una bestia, il lupo cattivo, l’incompreso delle fiabe, come è incompresa lei. Sogna di riscattarlo, mentre varca il primo passo nel firmamento delle celebrità. Scrive il monologo del loro amore eterno, e recitarlo è come respirare, per buona parte della storia, finché neanche quel respiro basta più. «Ho amato una bestia, nelle notti d’estate mi mordeva con le cinque punte di una stella». La storia di Bianca dura una manciata di pagine, ma capaci di far provare a chi legge tutte le emozioni che esistono: fai il tifo per lei, provi compassione, la disprezzi, la guardi dall’alto in basso, pensi che se l’è cercata, desideri per lei tutto il male possibile e subito dopo tutto il bene possibile, vorresti tornare indietro di qualche pagina e non aver pensato tutti quei pensieri, vorresti restituirle l’infanzia e farla ripartire daccapo, che quei sogni lì non tornano più, dopo, desideri che all’irrimediabile si ponga rimedio. Neanche in questo c’è colpa. Perché Bianca è tutte noi, che da bambine ci mettevamo il rossetto della mamma e poi lo usavamo come microfono cantando davanti allo specchio. Bianca è noi, che guardavamo la televisione e volevamo entrarci dentro, e da là dentro guardar crepare d’invidia tutte le persone che ci hanno fatto del male. Bianca è noi, che a ogni mi piace ci sentiamo importanti, e quando in alto a destra della bacheca Facebook non c’è alcun quadratino rosso delle notifiche crediamo che il mondo si sia dimenticato di noi. Bianca è noi, è il limite che non varcheremo mai. Il lupo cattivo non mangia le persone perché è cattivo, ma perché è la sua natura: Bianca lo ha capito. Quello che non ha capito, non ancora, è che il lupo cattivo mai mangerebbe un suo simile. Bianca da morire, romanzo di Elena Mearini (Cairo Editore, 2016).
Ha lunghi capelli biondi, l’arabo del futuro, una boccuccia di rosa, occhi profondi e tondi. Si chiama Riad e nonostante i suoi due anni di età, questo nome gli è stato assegnato da molto tempo. Perché in Siria funziona così: i ragazzi, prima ancora di essere uomini, possono decidere il nome del loro primogenito maschio, prima ancora che esista, in una proiezione in avanti precoce e tutta al maschile. Così suo padre si faceva chiamare Abu Riad, “il padre di Riad”, prima di andare a studiare alla Sorbonne, prima di conoscere sua madre Clémentine alla mensa dell’università, prima di innamorarsene, prima, molto prima dei suoi occhi tondi, della sua boccuccia di rosa e di tutto il resto. Ci sono grandi aspettative che lo riguardano. Qualche volta Riad sogna di camminare in un lungo corridoio giallo senza soffitto e all’improvviso compaiono due tori che lo inseguono. Quando la speranza di salvarsi lo abbandona, una mano gigante lo afferra e lo porta in salvo: è la mano di suo padre. Si affida, Riad, come tutti i bambini. Cos’altro potrebbe fare? L’arabo del futuro di Riad Sattouf è uscito da pochissimo per Rizzoli Lizard in traduzione italiana, dopo aver venduto 200.000 copie in Francia ed essersi aggiudicato il Fauve d’or d’Angouleme 2015 come migliore opera. Lo cerco sullo scaffale, lo trovo (copertina nera e rossa, inequivocabile Gheddafi su sfondo di bandiere verdi) e come succede ad Alice con la tana del bianconiglio, ci cado dentro a capofitto. In Siria ero un francese, in Francia ero un arabo con un nome bizzarro dice di sé l’autore, e ci racconta proprio questa storia, una storia complessa di estraneità e di appartenenza, di regole apprese e sovvertite, di andate e ritorni tra la Francia, la Libia di Gheddafi e la Siria di Hafiz Al-Asad. E tutta questa materia complicata, intessuta di differenze culturali, di incomprensioni, di piccole e grandi violenze, ci arriva diretta come avessimo la pelle sottile dei bambini, senza spiegazioni, senza la possibilità di formarsi un’opinione univoca sulle cose, con quello spaesamento meraviglioso e terribile che accompagna le esperienze dell’infanzia. Ci arriva con forza e con leggerezza, grazie all’ironia che Sattouf, “scuola” Charlie Hebdo, riesce a trovare nell’ombra delle cose, anche quando non sembra possibile. E invece no, è possibile eccome. E si trova in libreria, comodamente tradotto nella nostra lingua. Io sono contenta di averlo letto. Riad Sattouf, L’arabo del futuro. Rizzoli Lizard 2015
Recensione di Marta Traverso. Incontra David Foster Wallace in un autogrill a due ore e mezza da Chicago. Un luogo così remoto che se non fosse per il suo accompagnatore Dan, a cui non sembra vero di poter conoscere di persona il suo idolo, Livia non lo avrebbe mai rintracciato. Mavis Gallant, invece, non sapeva chi fosse. È stato Mordecai Richler (quello de La versione di Barney) a spiegarle – con buona pace di Alice Munro – che era la più grande scrittrice canadese vivente. Oltre cento racconti pubblicati sul New Yorker, fra le altre cose. Livia e Mavis sono diventate ottime amiche, con il passare degli anni. Paula Fox la riceve in casa sua. Ha novant’anni, e fatica a ricordarsi cosa ha detto un istante prima. Suo marito Martin Greenberg, novantacinque anni, è al piano di sopra a lavorare a una traduzione di Von Kleist. Di sua nipote Courtney Love (sì, proprio lei, vedova Cobain) non ne vuole parlare. A onor del vero, sono molti i temi tabù, almeno in quella fase iniziale di diffidenza tra intervistatrice e intervistato. Finché scatta la scintilla, chimica, incontro di anime, chiamatelo come vi pare. Livia Manera Sambuy ha intervistato molti scrittori e scrittrici nei suoi viaggi lungo gli Stati Uniti, e si è sentita spesso dire: non parliamo di questo, né di quest’altro, «ti proibisco di scrivere di me». Da qui il titolo Non scrivere di me (Feltrinelli, 2015), Livia che socchiude la porta del suo mondo, ci lascia scorgere tra le valigie e i passi affrettati, da Parigi a New York, da Milano al Madagascar, in tasca il suo amore per la letteratura americana, uno dei lavori più belli che ci siano, il suo. So solo che è la mia vita, la vita di una persona che ha fatto del leggere il proprio mestiere. Anche Philip Roth era diffidente, tanto che la prima volta non volle neppure incontrarla. Quattordici ore (o giù di lì) di aereo e tutto quello che è disposto a concederle è una telefonata? Si è fatto perdonare con un invito a cena. Ne è nato un legame oltre ogni immaginazione, tanto da far dire a Roth “Avremmo dovuto incontrarci venticinque anni fa. Avremmo cambiato le nostre vite”, tanto da regalare a noi il documentario Philip Roth. Una storia americana, che Livia ha pazientemente diretto. Lei fu tra le prime persone a ricevere la notizia, con mesi di anticipo rispetto al resto del mondo: “Mia cara, è arrivato il momento di tirare giù la saracinesca e chiudere bottega. Perché abbia buttato via la mia vita con i libri e con le donne è un mistero” Ed è stato proprio Roth a suggerirle l’intervista a Judith Thurman, autentica ispiratrice del film La mia Africa. Lui l’ha conosciuta dopo averle scritto una lettera di ammirazione per la sua biografia di Karen Blixen. Sì, ricevere una lettera di ammirazione da Philip Roth. Quando Livia entra nell’ufficio di Joe Mitchell, nella sede del New Yorker, non le sembra vero che quell’anziano redattore così dedito al lavoro non pubblichi più nulla dal 1964. Il suo romanzo più celebre è la biografia di Joseph Ferdinand Gould, il bizzarro scrittore che traduceva poesie nella lingua dei gabbiani. Realmente esistito, googlare per credere. Poi James Purdy, il genio prigioniero di un’epoca in cui l’orientamento sessuale di una persona – se di dominio pubblico – poteva mettere in ombra tutto il resto. E di uomini nell’ombra scrisse, per tutta la vita. Livia lo ha incontrato una sera che c’era una forte tempesta di neve e, come tutti, anche James ha socchiuso davanti a lei un pezzetto del suo mondo. La sua valvola di sfogo fin dall’infanzia? Scrivere rabbiose lettere anonime che poi non spedisce. Il solo scriverle basta a rilassarlo, almeno per un po’. E che emozione Richard Ford, mentre le racconta di quella volta che lui e Raymond Carver videro una ragazza bellissima uccidere e spiumare un’anatra a colpi di accetta, si guardarono l’un l’altro e dissero: «Scommettiamo che ti batto e arrivo prima io a metterla in un racconto?» «Scommettiamo di no?»
- 1
- 2