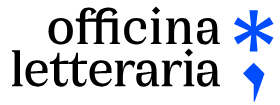Recensione
di Marta Traverso.
Incontra David Foster Wallace in un autogrill a due ore e mezza da Chicago. Un luogo così remoto che se non fosse per il suo accompagnatore Dan, a cui non sembra vero di poter conoscere di persona il suo idolo, Livia non lo avrebbe mai rintracciato.
Mavis Gallant, invece, non sapeva chi fosse. È stato Mordecai Richler (quello de La versione di Barney) a spiegarle – con buona pace di Alice Munro – che era la più grande scrittrice canadese vivente. Oltre cento racconti pubblicati sul New Yorker, fra le altre cose. Livia e Mavis sono diventate ottime amiche, con il passare degli anni.
Paula Fox la riceve in casa sua. Ha novant’anni, e fatica a ricordarsi cosa ha detto un istante prima. Suo marito Martin Greenberg, novantacinque anni, è al piano di sopra a lavorare a una traduzione di Von Kleist. Di sua nipote Courtney Love (sì, proprio lei, vedova Cobain) non ne vuole parlare.
A onor del vero, sono molti i temi tabù, almeno in quella fase iniziale di diffidenza tra intervistatrice e intervistato. Finché scatta la scintilla, chimica, incontro di anime, chiamatelo come vi pare. Livia Manera Sambuy ha intervistato molti scrittori e scrittrici nei suoi viaggi lungo gli Stati Uniti, e si è sentita spesso dire: non parliamo di questo, né di quest’altro, «ti proibisco di scrivere di me».
Da qui il titolo Non scrivere di me (Feltrinelli, 2015), Livia che socchiude la porta del suo mondo, ci lascia scorgere tra le valigie e i passi affrettati, da Parigi a New York, da Milano al Madagascar, in tasca il suo amore per la letteratura americana, uno dei lavori più belli che ci siano, il suo.
So solo che è la mia vita, la vita di una persona che ha fatto del leggere il proprio mestiere.
Anche Philip Roth era diffidente, tanto che la prima volta non volle neppure incontrarla. Quattordici ore (o giù di lì) di aereo e tutto quello che è disposto a concederle è una telefonata? Si è fatto perdonare con un invito a cena. Ne è nato un legame oltre ogni immaginazione, tanto da far dire a Roth “Avremmo dovuto incontrarci venticinque anni fa. Avremmo cambiato le nostre vite”, tanto da regalare a noi il documentario Philip Roth. Una storia americana, che Livia ha pazientemente diretto. Lei fu tra le prime persone a ricevere la notizia, con mesi di anticipo rispetto al resto del mondo:
“Mia cara, è arrivato il momento di tirare giù la saracinesca e chiudere bottega. Perché abbia buttato via la mia vita con i libri e con le donne è un mistero”
Ed è stato proprio Roth a suggerirle l’intervista a Judith Thurman, autentica ispiratrice del film La mia Africa. Lui l’ha conosciuta dopo averle scritto una lettera di ammirazione per la sua biografia di Karen Blixen. Sì, ricevere una lettera di ammirazione da Philip Roth.
Quando Livia entra nell’ufficio di Joe Mitchell, nella sede del New Yorker, non le sembra vero che quell’anziano redattore così dedito al lavoro non pubblichi più nulla dal 1964. Il suo romanzo più celebre è la biografia di Joseph Ferdinand Gould, il bizzarro scrittore che traduceva poesie nella lingua dei gabbiani. Realmente esistito, googlare per credere.
Poi James Purdy, il genio prigioniero di un’epoca in cui l’orientamento sessuale di una persona – se di dominio pubblico – poteva mettere in ombra tutto il resto. E di uomini nell’ombra scrisse, per tutta la vita. Livia lo ha incontrato una sera che c’era una forte tempesta di neve e, come tutti, anche James ha socchiuso davanti a lei un pezzetto del suo mondo. La sua valvola di sfogo fin dall’infanzia? Scrivere rabbiose lettere anonime che poi non spedisce. Il solo scriverle basta a rilassarlo, almeno per un po’.
E che emozione Richard Ford, mentre le racconta di quella volta che lui e Raymond Carver videro una ragazza bellissima uccidere e spiumare un’anatra a colpi di accetta, si guardarono l’un l’altro e dissero:
«Scommettiamo che ti batto e arrivo prima io a metterla in un racconto?»
«Scommettiamo di no?»