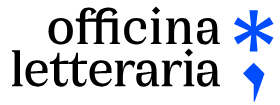Torna dopo un anno il Laboratorio Officina Ragazzi, dedicato ai giovanissimi che vogliono avvicinarsi presto (o si sono già avvicinati prestissimo) al mondo della scrittura. A tenere il corso sarò proprio io, e ci incontreremo sei volte (ogni martedì dal 17 marzo al 21 aprile, dalle 17:00 alle 18:00 alla sede di Officina Letteraria, in […]
Perché infilarsi nella tana di Coniglio Bianco di Anselmo Roveda. Scrivere è un piacere, certo. Ma è anche un mestiere. Da fare bene, come ogni mestiere. Mal tollereremmo un idraulico, un panificatore o un elettrauto improvvisati, dopo esserci rivolti a loro non dovremmo avere più sgocciolii nell’acquaio, assaggiare pane sciapo, restare fermi su una piazzola […]