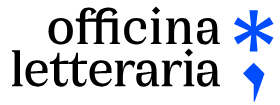Settimo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo! L’oste onesto (oppure no) e il frate alcolizzato (oppure no) di Elena Genisio Percorro faticosamente la salita che porta alla parrocchia; è ripida e le pietre sono arse dal sole, così come la mia testa; provo un senso di vertigine. Arrivo ad appoggiarmi al portone e finalmente entro. Mi investe una folata d’aria fresca, che mi rigenera. Intravedo quel frate solitario osservare con sguardo vacuo, quasi assente, l’altare della chiesa di Apricale. Sembra fuori posto, guarda gli affreschi alle spalle dell’altare come se non li vedesse davvero. Poi abbassa lo sguardo verso i mosaici colorati del pavimento e intravedo in lui un guizzo di ammirazione. Si muove lentamente, trascinando il suo ruvido saio con passo greve, tocca spesso il cordone che gli stringe la vita, aggiustandolo in continuazione, come se non ne fosse mai soddisfatto. La sua statura supera quella di un uomo di media altezza e la sua magrezza lo fa apparire anche più alto. Percorrendo la navata centrale, incrocio il suo sguardo acuto e penetrante; il naso affilato e un po’ adunco gli conferisce un’espressione vigile, precisa. Possiede un mento pronunciato, segno di volontà salda… Possiede un mento pronunciato, segno di volontà salda; il viso è allungato e coperto di efelidi, che sbocciano da una barba grigia scolpita con cura. Ritengo possa avere cinquanta primavere, ma il suo corpo si muove agile. All’improvviso lo vedo cambiare direzione per dirigersi deciso verso l’altare, sale velocemente i gradini che lo separano dal tabernacolo e compie un gesto inaspettato. A fianco del tabernacolo, dove vengono custodite le ostie da consacrare, qualcuno deve aver dimenticato il vassoio d’argento su cui è appoggiata la bottiglia contenente il vino per la messa. Il frate solleva il tovagliolo di lino bianco appoggiato sulla bottiglia, ma si arresta per guardarsi rapidamente attorno, furtivo, per verificare se ci sia qualcuno in chiesa. Io, nel frattempo, mi ero già nascosto dietro una colonna marmorea, in modo da osservare la scena senza essere visto da lui. Il frate, certo d’essere solo, afferra la bottiglia e, avido, beve il vino fino all’ultima goccia. Questa scena mi lascia esterrefatto. Finito di bere, porta le mani al cordone in vita per aggiustarlo compulsivamente, un movimento che sembra rassicurarlo. Fatto questo, si dirige a lunghe falcate verso l’uscita della chiesa, con lo sguardo basso. Nel frattempo, sono uscito dal mio nascondiglio, lui, passandomi accanto, senza vedermi, mi investe con un odore peculiare, aspro, direi alcolico, a me familiare e mi accorgo che il suo colorito è pallido ma acceso solo sulle guance di un rossore innaturale. Ho la sensazione di conoscere questo frate sgualcito. Questo frate, sotto il suo vecchio saio sciupato dal tempo, sembra custodire e celare con fatica un segreto. Forse la ragione che lo ha guidato verso la bottiglia. Sempre più incuriosito e attratto da quest’uomo, decido di continuare a seguirlo con discrezione per scoprire cosa gli sia accaduto, quale sia il suo segreto. Lo vedo sparire in un vicolo stretto. Entrato a mia volta nel caruggio, non vedo più il frate. Evidentemente ha allungato il passo e ha inforcato uno dei sentieri che portano fuori dal paese. Non provo a seguirlo per strade più scoscese, mi volto per tornare in piazza. Nei pressi dell’antico forno, incontro una donna con lunghi capelli corvini, che tiene per mano un bambino che potrà avere una decina d’anni. Dalla tenerezza che c’è tra loro è evidente che si tratti di madre e figlio. La donna è bella, ma un po’ sfiorita, sembra stanca; il bimbo mi colpisce particolarmente, non le somiglia affatto, ha colori diversi, capelli rossi e una pioggia di efelidi sulle guance. Quei caratteri mi risultano familiari: riconosco in lui i tratti di quel frate misterioso, anzi sembra lui in miniatura. “Ma come mai? È possibile che tra loro esista un qualche vincolo di parentela?” La donna trasporta con fatica una borsa pesante, vedendola in difficoltà le offro il mio aiuto. Intanto ne approfitto per scrutare meglio il bambino. “Signora, mi permetta di aiutarla… posso fare le veci di suo marito e portarle la borsa fino a casa? È pesante e lei deve badare anche al suo bambino.” E lei: “La ringrazio molto, abitiamo qui vicino” e guardando il bambino “è Francesco l’uomo di casa, siamo soli io e lui”. Dopo una discesa di pochi passi, raggiungiamo una casa graziosa, con un piccolo giardino e con finestre fiorite di gerani. “Eccoci arrivati!” esclama Francesco. Deposta a terra la borsa, mi congedo dalla donna e mi allontano. Nel frattempo, appare il frate, assorto, di ritorno dal suo vagare. Mi fermo di nuovo a osservarlo. All’improvviso viene investito da una palla: è Francesco che gioca con la sua mamma nel giardino. Il frate raccoglie la palla, alza lo sguardo e vede la donna. Lo vedo trasalire, immediatamente porta le mani al cordone del saio e le sorride istintivamente. Lei lo saluta con dolcezza: “Bernardo! Sono dieci anni che aspetto” dice. Un vecchio, seduto su una panca di legno poco lontana, assiste alla scena e si rivolge a me come se mi conoscesse: “Hai visto? Ti ricordi quando dieci anni fa Frate Bernardo è stato allontanato da Apricale? Ha vissuto per anni come un eremita, non si sa dove…”. Io che non ricordo nulla, guardo il vecchio con sorpresa, senza parlare. Il vecchio prosegue: “Ma sì… non era mai stata data una motivazione ufficiale per la sua partenza forzata, un esilio durato dieci anni. Poi è arrivato quell’angelo dai riccioli rossi, cresciuto solo con la mamma.” Ecco svelato il mistero di quella somiglianza. Il frate si avvicina quasi timoroso alla donna e al bambino, aggiustandosi il cordone del saio più nervosamente del solito. Allora il bambino prende l’iniziativa e gli corre incontro. Frate Bernardo toglie finalmente le mani dal
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. La casalinga perfetta la giornata di Angela La casalinga perfetta si alza presto, prepara colazione, caffè fresco, pane tostato, cereali, spremuta; sia che abbia una famiglia o che sia sola. Entro le ore nove la casa è pronta per un ricevimento. Cucina a posto, letto fatto, aspirapolvere passato, bagno disinfettato adatto a qualsiasi operazione chirurgica. Lei docciata, vestita, truccata, con la lista della spesa in mano e le buste riciclabili, si dirige al supermercato anzi ai supermercati. Perché ha chiarissimo in testa dove e cosa costa meno, dove e cosa è di migliore qualità, dove la raccolta punti offre regali più allettanti. Un paio di giorni alla settimana, prima della spesa, fa un’oretta di palestra: bisogna pur mantenersi in forma. Ecco, io, io no. Penso che quelle che ci riescono, come minimo fanno uso di qualche sostanza poco legale. Io appartengo alla categoria casalinghe single, quasi divorziate e scrause come direbbe una mia amica. E la vita è dura per donne come me, nonostante il grande privilegio di non dover combattere per il pane quotidiano. All’alba di ore che variano, ma sempre si avvicinano al mezzodì, apro il primo occhio annebbiato vuoi da quella quantità di alcool vagamente superiore alle dosi consigliate ingurgitata la sera prima, vuoi dalla notte insonne o da una dose di Lexotan presa un po’ troppo tardi. Apro un occhio, poi l’altro, inforco gli occhiali e cerco di capire dall’orologio o dal cellulare quanta parte di giornata ho già sprecato. “Non devo dormire così tanto, ci sono un mucchio di cose da fare in casa…” Inciampando nella bottiglia dell’acqua, negli stivali e nelle borse della spesa dimenticate in corridoio, raggiungo il bagno. Sulla tazza richiudo un attimo gli occhi, non sono ancora pronta ad affrontare la giungla. Libera dalle prime urgenze corporali, in vestaglia rosa pallido, punto il radar verso la cucina dove un avanzo di caffè mi aspetta e lo sparo dritto nel microonde, accasciandomi poi sulla panca per inzuppare un paio di biscotti, molli perché il pacchetto era rimasto aperto, in quel rimasuglio di liquido nero. Tirato il fiato per l’immane fatica, ci vuole ancora un po’ di caffè per mettersi in moto e ne faccio mezzo litro di quello lungo, tipo americano. Se avanza, domani è già pronto. Se non sono obbligata a uscire per impellenti ragioni, volontariato, corsi, visite mediche, pratiche burocratiche, infilo una tuta con cui ginnastica non l’ho davvero mai fatta. Un’ occhiata in giro e un sacro fuoco mi prende. “Ora metto tutto a posto, Sì!” Prima, però, meglio sedersi un attimo sul divano a controllare i messaggi del cellulare, un’occhiata alle mail per quell’ordine di tavolette di cioccolato ai cristalli di rosa di cui proprio non posso più fare a meno. L’occhio cade in basso a destra sullo schermo del p.c.: le 14.00? Ma, come è possibile ? Sarà rotto. No, sono proprio le due, forse dovrei mangiare ma ora non ho fame, ho fatto colazione da poco. E poi dovrei andare a fare la spesa, o scongelare qualcosa. C’è un po’ di polvere sulla libreria, ora pulisco. Scala, mangia polvere, straccetto magico, salgo. Porca…, i guanti, scendo per prenderli, il campanello della porta suona: lettura gas. Non ricordo di aver visto il cartello ma apro, è la signora che viene sempre. Mi scuso per il caos, è una misera finzione, non me ne frega niente, ma si fa così. Se ne va. Cosa stavo facendo prima? Mi scappa la pipì, vado in bagno, studio il bidet, sarà il caso di spruzzare un po’ di Cif, ma la spugnetta dov’è? Ho buttato quella vecchia tre giorni fa e quelle nuove sono ancora nel sacchetto. In soggiorno la scala aspetta, in corridoio i sacchetti aspettano. Il computer è ancora acceso, ricontrollo le mail. Mi ha scritto la mia amica dall’Olanda, devo assolutamente risponderle. Ok fatto. Ora spugnetta e pulire bidet. Il Cif si è seccato e la crosticina biancastra è dura da levare ma il risultato è ottimo: bidet come nuovo. A ben vedere anche il resto del bagno avrebbe bisogno di una passata, prima però ci vuole un po’ di aspirapolvere altrimenti poi cade l’acqua e faccio un pasticcio. Fuori l’aspirapolvere dallo sgabuzzino, già che ci sono lo passo anche in corridoio. Suona il telefono, è mia mamma che vuol sapere se vado a cena, se domani l’accompagno dal dentista, cosa sto facendo, se posso darle una mano con i vasi in giardino. “No mamma, oggi non ce la faccio, ho troppo da fare, magari domani ci risentiamo”. In soggiorno la scala aspetta, in corridoio i sacchetti aspettano in compagnia dell’aspirapolvere. Ora un certo languorino lo sento. Le 17:00? Ma, com’è possibile? Va bè, farò merenda: un tè ,un budino, un mandarino per le vitamine. Mia mamma ha parlato di piante, e le mie piante? Sul balcone un po’ ammosciate aspettano l’acqua e una buona
“No, non scrivo favole”. E non ho occhi a cuoricino. Luoghi comuni e letteratura per l’infanzia di Anselmo Roveda Prima di sentirmi dire che sono uno scrittore dovrete durare fatica. Anche per i miei vicini di casa è scoperta recente. Di solito ci giro intorno, non sono uno di quelli che si presenta come ‘scrittore’, anche se i libri sono, ormai da parecchio, parte rilevante del mio mestiere letterario – ché poi si fa pure cronaca e critica letteraria, traduzioni, formazioni, conferenze… I primi tempi evitavo solo per timidezza. E timore. Temevo che vista la assai nutrita compagnia circolante di autoproclamati scrittori, in ragione magari di un solo titolo variamente pubblicato (self, stamperia sotto casa, EPA, minuscoli editori mai o mal distribuiti…), si potesse scambiare l’affermazione per millanteria, vanteria, mancato senso delle proporzioni o, peggio, della realtà. Poi si cresce, i titoli si moltiplicano, le occasioni pubbliche ti smascherano e così ho smesso di negarlo. Certo, ci giro intorno un po’. Ma lo dico. Mi dilungo e infine, in una sorta di coming out, lo dico: “Sono uno scrittore”. E la cosa piace, un po’ ovunque, perfino nei baracci che amo frequentare e nelle sale operatorie che mi è toccato visitare di recente. Ora però c’è un problema, sia con l’avventore da “gotti” sia con il chirurgo ortopedico. Le domande seguenti, infatti, sono “quali libri hai scritto” e “quale tipo di cose scrivi”. Ecco, tanto più avendo presente i livelli di lettura nazionali, citare un proprio titolo non funziona, a meno che, a seconda dei gusti, non siate l’autore di Gomorra, Tre metri sopra la cielo, La strada verso casa, Seta o Il cane di terracotta. Sul “cosa scrivi” è più facile e difficile. Evito di dire che credo e pratico l’idea di ‘autore totale’, come dice Andruetto. E cioè che scrivo ‘di tutto’, anche prendendomi il rischio di non essere efficace in ‘tutto’ allo stesso modo. Dico direttamente che scrivo ‘di tutto’. Perché le storie, spiego, prendono strade e forme diverse: alcune cose riesco a dirle solo in poesia (e in genovese); altre solo in forma rappresentabile ad alta voce, magari in radio; altre hanno forma narrativa più tradizionale, racconti, talvolta con sfumature nere o fantascientifiche; altre storie ancora, e sono la più parte del pubblicato, mi viene voglia di accostarle a lettori giovani o giovanissimi. Anche qui declinando le forme: dal testo per l’albo illustrato, al soggetto per fumetti, alla narrativa. Insomma, scrivo soprattutto “per bambini e ragazzi”. Ecco, l’ho detto. L’interlocutore, primario e/o alcolista, di solito dissimula la delusione con un sorriso: troppo articolata la risposta per dirgli, alla fin fine, che scrivo per mocciosi e brufolosi. Poi come in un’illuminazione, sinceramente entusiasta, aggiunge: «Ah! Che bello! Scrivi favole». Ecco, no. Non scrivo favole. Le favole sono una forma ben specifica della narrazione, fin dagli antichi, e a dirlo tutta, al di là dell’ampia proposizione a ricaduta sul pubblico dei bambini, non sono esattamente un genere letterario dedicato in modo esclusivo all’infanzia, anzi. Ad ogni buon conto, sbirciando alla voce favola nell’Enciclopedia Treccani (disponibile anche online) troverete: “Breve narrazione per lo più in versi. Quando si parla di f. come genere letterario, ci si riferisce comunemente a quella i cui caratteri fondamentali furono segnati già da Esopo e universalmente diffusi da Fedro: essenziale è che essa racchiuda una verità morale o un insegnamento di saggezza pratica e che vi agiscano (a volte insieme a uomini e dei) animali o esseri inanimati, sempre però tipizzazioni e quasi stilizzazioni di virtù e di vizi umani”. Appunto. Non ho nessuna verità morale o saggezza pratica da propugnare. Non rappresento di solito nelle mie narrazioni bestie; e tanto meno, qualora le usassi, le caricherei allegoricamente di vizi e umane virtù. Mi è capitato di rinarrare favole e fiabe, ma questo è un’altro discorso, anzi due (e già: oltre al tema della riscrittura, bisognerebbe pure mettersi d’accordo su cosa sono le fiabe; chi è stato al corso di Officina me ne ha sentito parlare). Io faccio semplicemente letteratura, che diventa per l’infanzia o per i ragazzi quando incontra soprattutto lettori di quelle età. Racconto, di solito, storie di uomini e donne, di diverse età, che si muovono in un tempo e in un ambiente, talvolta reali talaltra fantastici. E sebbene non abbia verità morali o saggezze ad orientare la mia opera, sono costituto come ogni autore (ed essere umano) da esperienze e desideri capaci di ricomporsi in una visione del mondo e in un sistema di valori. La scrittura di ciascuno, così come ogni azione umana (autori e no), trae senso, forza e peculiarità proprio da questi elementi. È quello che cerchiamo come lettori. Quindi, certo, dentro la letteratura per l’infanzia troverete visioni del mondo, ma non diversamente che in tutta la letteratura e sicuramente non ridotte a schematismi moraleggianti. Almeno nella buona letteratura per l’infanzia; delle cose di poco conto è inutile dire (e quelle abbondano anche nelle altre forme di letteratura). In breve: non scrivo favole. E a dirla tutta detesto le storielle edificanti, a maggior ragione con animali che sanno perfettamente se stare dalla parte del bene o del male. C’è però in agguato un’altra conseguenza sociale nell’aver affermato di scrivere per bambini e ragazzi. Insidiosa, scivolosa. E già, perché il nostro interlocutore, quale che sia la sua cultura, di solito ha una seconda prepotente inferenza. Infatti, oltre a farsi convinto che tu scriva favole, riterrà immediatamente che tu sia bravo, nel senso di buono: dal cuore gonfio di buoni sentimenti e dalla testa piena di leggeri lineari corretti pensieri. Una persona con una vita leggiadra e colorata come immagina siano (e per fortuna non sono) le illustrazioni per bambini. Del resto – pensa, in vasta compagnia, il nostro interlocutore – chi si occupa di bambini, fosse anche solo per scrivere storie loro dedicate, è sicuramente una persona buona, semplice, forse anch’essa infantile, libera dalle preoccupazioni e dalle miserie del mondo adulto. Spiace dirlo, ma oltre a non scrivere favole non sono neppure buono. Chi scrive per bambini fa
Sesto racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo! Il barone rampante (oppure no) e l’oste onesto (oppure no) di Licia Valente Mi sono appoggiato alla balaustra sul sagrato della chiesa. La gente è più bella vista dall’alto. Ricci arruffati, cocce pelate che brillano al sole, ventri gonfi sotto bazze di tordo. Ride il gatto, è disgustoso mentre ammicca e si prende confidenza, quasi fosse uno di noi. Chi siamo noi? Ero un barone, lo so per certo, ché non mi piace star appresso agli altri, né gli altri amano avvicinarsi a me. Chi sono gli altri? Cavalieri, mocciosi, chierici derelitti, musici e contesse decaduti hanno steso sulla piazza le loro vite senza più orme una vicina all’altra. Siamo fantasmi appesi al campanile, in balia del vento che non viene a portarci via. La porta del castello stride con le rondini, si apre su un giardino ombroso che guarda il borgo dall’alto, come me. Senza più una storia che segni il mio confine, provo a immaginarne altre, una per ogni testa. Qual è la tua, oste che ti dici onesto? Le tue spalle piccole si sono posate come un velo sulle pietre aguzze. Hai dormito il sonno dei giusti e ti sei svegliato che non eri più tu. Sarai davvero onesto? Dal fondo del mio nulla ormai perduto suona una nenia antica: L’oste onesto si muove lesto. Non è mai mesto l’oste onesto. Ha le mani fini e sottili, di chi sa dove vuole metterle le mani, e dove tenerle fuori. In sogno, dita simili, di donna, si infilano nel solco della memoria e della mia schiena. “Diritto, devi stare diritto”. La voce che risale da lontano, gira intorno a una tavola imbandita, non ha volto né nome. L’oste sorride a tutti, non separa mai le labbra. Non dice, lascia dire. Annuisce spesso, quasi annotasse un parere da prendere in prestito. Per lui, siamo solo passanti dentro una taverna senza nome o luogo, in una notte senza memoria, uno a fianco all’altro, lo sguardo fisso alla bicicletta appesa al campanile, che nessuno la può rubare. Seduto al lavatoio, l’oste fissa il vuoto e stringe le mani l’una dentro l’altra. Dove vuoi tornare, oste onesto? Un oste è onesto solo se non è un oste. Dalla mia balaustra, osservo la lapide su cui vorrei leggere chi sono stato. Una voce straniera fende l’aria alle mie spalle. Mi inchino d’istinto. “Bonjour mademoiselle l’artiste”, e son già pronto a balzare sul parapetto, di nuovo in alto, lontano. L’ amazzone del popolo che ho davanti non è certo demoiselle, ha mani ruvide con cui si carezza le guance cosparse di vene sottili. – Bonjour, mi dice. – Vous n’êtes donc pas l’artiste? – Eh bien non. Sono l’ostessa, per servirvi, Monsieur. – È incredibile c’è qui tra noi smemorati anche un oste, forse onesto, o almeno comme ça il dit. Forse lo conoscete? – Monsieur mio caro, mi dice allora lei, tout le monde le sait che un oste è onesto solo se non è un oste! Ride così argentina che mi scappa la voglia di saltar sul mio poggio. Ha fianchi larghi e seni poderosi che tiene a bada con le mani mentre ride. E’ desiderio quello che provo? Ho avuto un grande amore? Forse mai. – Ditemi però, Madame, lo avete mai conosciuto, voi, un oste onesto? – Oh moi? Bien sur, certo che sì. Questo sette di luglio non c’è la luna, che se l’è mangiata il gatto, dopo la lucertola. Lei è tornata sotto la mia balaustra. Da lì mi ha detto del suo amore perduto in una notte di nera magia. Oste, hai avuto più di una vita e più di un volto. Eri tu quel giovane delicato e buono, per davvero hai amato e per amore hai abbandonato altezze e distanze. Svelato è il tuo mistero, oste onesto: fosti Alberico, nobiluomo innamorato di una scalcinata forestiera senza passato o blasone. Nel borgo fu l’incontro, per lei lasciasti onore e lustro appesi al gran camino delle feste, nel castello ai piedi del monte. Al borgo passò la strega quella notte e quando tornasti a questo borgo appeso, le campane non si mossero a salutare il tuo ritorno d’eroe senza trofeo. Ti dissero allora che se n’era andata. La notte del 3 di Luglio, quella volta. la strega rubò a lei, straniera, la memoria e a te l’amore. Senza una parola, era fuggita a un passato che credeva per sempre perduto, mentre il gatto rideva, tenendo tra le unghie la vostra storia, come un topo che muore. Senza più nome né amore, cercasti un luogo straniero e ti facesti oste tu stesso, a eterna memoria del sogno fuggito. Sei davvero onesto, oste, perché oste davvero non sei. Per questo sei tornato qui, a cercarla una volta ancora. E sei rimasto tu, questa volta, prigioniero tra le fauci della strega e del gatto. Mi guarda sconsolato, quel nome davvero non è più il suo. “Non sono più io quell’uomo, io sono l’oste portami via al mio banco e al mio grembiule.” Lei spunta da dietro le mie spalle, – Sono io. Sono qui. La seguo scendere lenta, verso di lui. È una stella che scende dentro gli occhi spalancati di lui. Sono quattro ora le mani intrecciate e hanno la forza dell’edera, per non lasciarsi più. Il gatto ulula dal fondo del pozzo. – Finalmente ti ho trovata, le sussurra lui. – Sono io che ho ritrovato te. Leggi gli altri racconti di Apricale 2016!
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. Ancora un’altra giornata la giornata di Sara Sono molto stanca. Sono sempre molto stanca, io. Non si tratta della quantità di cose che faccio in una giornata, certo ne faccio molte, ma non è quello; in una condizione diversa potrei farne altrettante senza essere inguaribilmente stanca. La mia stanchezza è sintomo d’una malattia chiamata abitudine al dovere. Mi esercito con diligenza a questo tipo di abitudine per rassegnazione ed inevitabilità: manco di una strategia alternativa e davanti alla mia disperazione di cambiare le cose ogni progetto si arrende. Il fatto è che andare a rinchiudermi in una stanza, popolata da persone che non ho necessariamente scelto di vedere nove ore al giorno, non mi va proprio giù. Non è per queste persone tuttavia, col tempo abbiamo modulato il nostro essere umani in una vicinanza forzata, abbiamo creato un equilibrio, un clima dopotutto; il fatto è che ho una lunga serie di motivi per essere stanca. Ad esempio, la mia sveglia suona alle sette ogni mattina, e non dico che vorrei dormire, ma che vorrei smetterla di dover correre ogni giorno come se stesse per finire il mondo e mi fossero rimasti solo pochi minuti per salutare la mia famiglia per l’ultima volta, quando lo scopo della mia frenesia in realtà è non timbrare in ritardo un’entrata al lavoro. Ad esempio, odio gli spazi piccoli e sovraffollati e l’ufficio in cui lavoro è un quadrato in un rettangolo di tanti altri quadrati in cui ci si è dati parecchio da fare per aumentare la densità di popolazione per metro quadro. Ad esempio, ci sono giorni in cui vorrei andare a farmi una passeggiata in riva al mare o restare a casa a scrivere il mio romanzo che non finisco mai o andare a leggere un libro in una locanda sorseggiando quel caffè che non posso bere perché il mio colon-irritabile-sempre-irritato me lo impedisce. Ad esempio, fissare un monitor come un serpente che ne ha subito l’incantesimo, restare seduta nella stessa posizione per molte ore, compiere numerosissime ripetizioni in un processo di click automatizzati, sollecitare senza tregua chi mai risponde non mi piace. Ad esempio, lavorare duro, lavorare seriamente, trovare persino un senso alla fine di quelle giornate – che si ricalcano con una precisione tale da farmi dubitare che stia vivendo la stessa unica giornata da molti anni – mi pare un’illusione nel momento in cui mi accorgo che conta solo ciò che appare. Ad esempio, mangiare con un cronometro da centometrista puntato sulla testa a scandire la mia tregua di quarantacinque minuti mi fa restare il pranzo sullo stomaco perlopiù. Ed ecco che il mio apparato digerente mi dichiara sciopero e, almeno lui, di lavorare proprio non vuol sapere. Ad esempio, dopo otto ore di lavoro vorrei uscire; e molto spesso lo faccio, ma il senso di colpa per tutte le cose che ogni giorno lascio da finire viene a farmi visita la sera, quando passo in rassegna tutte quelle maledette scadenze che si accalcano in quella che sembra essere una linea unica, sempre più spessa, su un giorno del calendario. Un calendario in cui numeri sono vaghi ricordi, al di là di queste linee spesse. Poi, quando alla fine riesco ad uscire, viene la stanchezza a prendermi. Il resto della giornata è la coda di un’animale lungo, il cui corpo ormai è uscito dal mio campo visivo da un pezzo. O come titoli di coda di un film che avrei voluto vedere, se fossi arrivata in ritardo per ritrovarmi sulla poltrona del cinema quando gli altri ormai se ne stanno per andare. Quella coda è il mio tornare a casa, accorgermi che non posso avere la pretesa che la cena si sia preparata da sola, decidere per principio o per rispetto che io e mio marito non possiamo fomentare l’industria dei cibi surgelati e mettermi a cucinare, lavarmi e poi lavare il bagno, decidere se fare una lavatrice o tirare avanti, decidere se stirare o tirare avanti, tentare di scrivere qualcosa ma smettere dopo mezz’ora perché l’emicrania incombe, accorgermi che alle nove e quarantacinque sto per addormentarmi e arrendermi in attesa di un’altra giornata come questa. Sono molto stanca. Sono sempre molto stanca perché continuo a vivere giornate come queste, che passano inosservate perché assolutamente normali per l’uomo moderno.