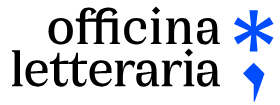Ecco i cinque racconti finalisti!
Votate il vostro preferito per mezzo di un like alla foto corrispondente sulla pagina Facebook di Officina entro le ore 12:00 del 10 settembre 2016.
L’autore o l’autrice del racconto con il maggior numero di voti vincerà un’iscrizione gratuita al Laboratorio di Primo livello “Grammatica delle Storie” 2016/17.
Gli altri quattro finalisti potranno invece usufruire dello sconto del 15% sul costo del Laboratorio.
Grazie ai numerosi partecipanti e all’amico Alberto Casiraghy per averci ispirato con il suo incipit.
Buona lettura!
“Ora di buio su un pianeta intraprendente” (Giulia Badano)
Prima o poi entrerò nel cuore del mondo, ma lasciate almeno che mi presenti, così che la mia speranza a tinte fosche e amare abbia il privilegio dell’identità.
Sono rinata circa quattro miliardi di anni fa dopo un’esplosione cosmica che ha sconvolto tutto. Non ho memoria di cosa fossi prima, probabilmente un pianeta come adesso, abitata da altri organismi che mi hanno amata e odiata fino al nebuloso collasso. Nella lenta ma costante dilatazione dell’universo ho vagato per lunghi eoni del tempo, senza meta, senza soluzione, in guisa di particella abbandonata a sé stessa ad oscillare per exametri indefiniti. Vita dura, quella della particella. I più massicci residui di materiale cosmico ti prendono a spallate per accaparrarsi il posto ritenuto migliore a loro unica discrezione, senza riuscire ad ammettere di essere più confusi di me. In realtà, in un mare di polveri bollenti, avevamo tutti perso l’orientamento e lo scopo della nostra esistenza, quale che fosse. E’ stato durante questa situazione di profonda incertezza e smarrimento che ho perso particelle a cui sentivo di voler bene. Annichilite dal calore infernale, hanno varcato la linea congelata e abbracciato il ghiaccio, scoprendo quanto quell’elemento possa essere magnifico e terribile e bastare di per sé. Una di loro si è guadagnata il nome di Nettuno. Dal canto mio, vagabonda errante e solitaria, non ho saputo scegliermi un angolo di universo senza prima chiedermi cosa volessi diventare. Ho impiegato meno tempo del previsto: qualche millennio, per sfiorare l’idea della completezza delle forme e dei climi. Nelle infinite pieghe del cosmo ho incontrato un granello brillante, circondato da un alone di argentata luce riflessa e discreta, con cui ho deciso di trascorrere il resto della mia esistenza a tre passi dalla nuova Fiamma che ci intiepidiva senza bruciarci. Io e il granello abbiamo trovato il nostro posto nello stesso isolato e cominciato a formarci al ritmo scandito dai suoi sorrisi un po’ sghembi, un po’ malinconici, dalle sue forme ciclicamente tonde, sbeccate, consumate, frizzanti, stanche. Crescendo accompagnata dai suoi umori mutevoli, ho dato forma all’esistenza, ho partorito terre e mari, ho innalzato montagne spruzzandole di neve, ho sguinzagliato il vento, ho addensato le nuvole e liberato il fulmine, ho rinfocolato il mio cuore con fluidi incandescenti e l’ho protetto avvolgendolo in mantelli solidi e compatti. Ho eretto templi ombrosi con radici, tronchi e rami, ho soffiato la sabbia su vaste distese di deserti ostili, ho generato microrganismi e vegliato sulla loro costante evoluzione. Anche sulla vostra. Così nudi. Senza denti aguzzi né artigli, senza ali per volare né branchie per immergersi, avete costruito armi, inventato scafandri per le profondità abissali e uccelli di ferro per solcare i cieli. Io ho amato la vostra astuzia, ho ammirato il vostro ingegno, ma ho sofferto nel vedervi ergervi a padroni miei e di voi stessi. Ho pianto lacrime di pioggia, mentre i vulcani hanno rovesciato la mia collera rovente. Mi sono spezzata gridando di dolore sotto scosse di terremoti violenti. Ho provato a vegliare su di voi, e quante vite ho visto accendersi e spegnersi, quanti passi ho sostenuto. Ma quante ruote, e chiglie, e rotaie, e trivelle e bombe mi hanno segnata. Quanto sangue ho dovuto bere e nascondere, quant’acqua ho dovuto accogliere per sentirmi pulita. Non so come faccio a essere così stanca e paziente, come sopporto di essere stata divisa in confini, tagliata da muri, frazionata da recinti e cancelli, a perdonare l’arroganza che vi rende indifferenti a ciò che calpestate.
Prima o poi entrerò nel cuore del mondo, nel vostro cuore, e ricambierete l’amore che vi ho offerto senza pretese. Ma forse sarà tardi. Prima o poi vi guarderete indietro, e nella triste desolazione che avrete lasciato scoprirete l’impronta indelebile delle vostre colpe.
“Orfeo ed Euridice” (Ilaria Carrozzo)
Prima o poi entrerò nel cuore del mondo. “Si inizia scavando”, mi dicesti, seduta di fronte a me al tavolo della cucina, palpebre calde, girasoli al tramonto, il profumo di una bambina, le mani tese sopra la tovaglia ruvida come un’anziana cartomante, mostrandomi le unghie, tanto gialle da sembrare l’escrescenza dell’osso.
Io cominciai da ragazza, grattando la porta di casa, impaziente di uscire come un cane d’appartamento, scattando fuori con una violenza nuova, la stessa di chi calpesta i gradini per raggiungere il proprio sedile in cima allo stadio. Le dita galleggiavano nell’aria, confuse, in attesa di impulsi. Fissavo atomi annoiati e scintillanti muoversi davanti alle pupille come nubili sospiranti a una festa.
“Graffia le persone, i muri, le strade”. Le sillabe si attaccavano tra loro, mescolandosi, il tuo profilo era quello di una madre determinata che parlava con la voce di chi ha fumato l’ansia di essere schiacciata dal corpo morto di una vita che non ha mai sentito sua.
Raggiungevo la scuola con l’energia rumorosa di un’onda, mi abbattevo su fiori che volevano essere forti, felpe e camicette orgogliose, ricordo che avevano profumi invincibili. Incidevo lettere sui banchi e li osservavo, rumorosi come canoni in una cattedrale durante una messa di Natale.
“Lascia segni su tutto quello che vedi, solleva la superficie, delicatamente, come la corteccia di un albero, poi ruba un pezzetto dell’anima, sbriciolalo sui polpastrelli e usalo per tracciare il tuo rifugio, fuori di qui, perché in fondo scappare è trovare il proprio posto nel mondo, il tuo centro, il suo cuore, pulsante e chiassoso, rumore di zoccoli che ti porta via”, i tuoi occhi grandi, alieni, iridi blu scure ricordavano notti d’agosto sull’asfalto umido, ombre che respiravano e si levigavano, lontano da casa, i volti lividi di genitori e parenti, le vene sotto la pancia tesa a pelle di tamburo, la cucina opaca di un solitario bilocale in centro, la gemma con cui lui era ritornato per farsi perdonare prima di scomparire ancora.
Alla fine del liceo mi fissavo le falangette, bianche, cirri tiepidi, rendendomi conto del tempo che mi si stava sfilacciando addosso come le calze sui muretti dietro la discoteca. Vent’anni e una vita che non scalfisce, non raccoglie, non costruisce, che si siede su una panchina e si lascia sfiorare dalle foglie e infine si accontenta di rovinare lo smalto per tirare fuori cartucce inceppate da una stampante difettosa in un ufficio all’ottavo piano, il vetro della finestra svolazzante di post-it e le bustine di integratori nel portapenne; amici che sono diventati note su spartiti persi e una madre lasciata sola in un’altra città.
“Crei tu il cuore del mondo, con le melodie che canti alle mollette mentre stendi il bucato, i versi che hai voluto imparare a memoria in un pomeriggio piovoso, i movimenti che ami fare quando sai di essere osservata, i quadri che hai stampato e appeso sui muri, gli incarti che non hai mai avuto il coraggio di buttare, i finali dei tuoi film preferiti, gli appunti a penna sui margini, la buffa mania di un tuo amico che non hai potuto fare a meno di imitare, le conversazioni che ricordi a distanza di anni, quelle in piedi fuori da un bar chiuso da ore, i vestiti che hai portato fino a logorarli, il profumo del mare di notte, i complimenti degli estranei, gli origami sulle panchine”, e nel frattempo sorridevi alle briciole di pane e io ora penso a noi come a una statua di Rodin. Io mi fondo alla realtà, ballerina che gira sopra un carillon, e non mi posso sottrarre, creare illusioni; tu mi sfuggi verso la luce che hai sempre fissato tanto intensamente da bruciarti gli occhi.
La nebbia qui è così fitta da sembrare una ragnatela, non ti vedo più.
Buon viaggio madre, torna a prendermi.
“Suberificazione” (Margherita F. Ravetti)
Prima o poi entrerò nel cuore del mondo, intanto ti racconto una storia?
C’è un lupo grigio, c’è un incrocio tra una montagna e un cucciolo, c’è un uomo che sembra un albero.
Quest’uomo cammina, mangia e non spreca, canta, forse prega.
Sa i nomi dei fiori, allora sì, prega.
È gentile e dedicato, ha mani delicate che si muovono come farfalle vecchie.
Mi ha fatto un incantesimo verde e oro: ha detto forte ‘Vieni’ e io l’ho visto, è passato dagli occhi, ho sentito il suo odore e gli ho aperto tutto.
Lui mi è padre e madre, maschio e femmina, protezione e cura, con lui torno nella resa.
Dice ‘sacro’ e dice ‘sesso’ e io ricordo, so, che così deve essere.
Quando lo penso nella testa sento la sua voce che ripete ‘semplice’, con le e aperte e dolci.
Non so perché lo dice ma ‘semplice’ mi sembra un gran promessa.
Ha un letto arancione in una stanza piena d’aria dentro una casa grande in mezzo a parole belle che suonano come le campane a vento.
Qual è la storia?
‘Sento che posso farti del bene’.
Mi insegna l’abbraccio, imparo il suo sesso e il suo sonno, con lui nel suo tempo è tutto lieto, prezioso, pulito.
Io ci credo tanto e sboccio.
Mansueta, sedata, indosso il laccio e mi ricovero da sola nel recinto dorato di un amoreterapia.
Non scappo più, posso fermarmi?
Come Gretel provo a ingrassare. Fiorisco. Sciolgo.
Il mio cuore è dappertutto, è come il motore del frigo di quando eravamo piccoli che da zitto all’improvviso iniziava a muggire e batteva e ronzava e friggeva come un animale che ha paura o come un cuore che ha paura.
Come un cuore appena nato, come un cuore che se ne sta andando.
Poi piano piano. Poi non è più tutto così morbido e caldo.
‘Il mio cuore è impigliato. Cosa succede se esco là fuori e mi innamoro?’
Non bastano i corpi incollati, le favole e gli umori scambiati nell’arancione del letto sudato.
Il lupo non è cattivo, cerca altro, là fuori nel mondo, sorride sempre ma le sue ossa lunghe vibrano leggere.
Vorrei sembrargli bella ma non ho riccioli in testa e centimetri sui fianchi, ho perso decimi e turgori, il liscio delle unghie, le dita dei piedi distese, la pelle senza macchie.
Io voglio leggere poesie e toccargli la faccia e il cazzo, voglio l’invito a fare tana in mezzo a tutto quel verde, nella culla della sua cantilena, sempre.
Io voglio per sempre.
Dov’è il suo cuore?
Lui sorride ancora, mi tiene e mi allontana insieme.
‘Il mio cuore è intrappolato’.
Il suo cuore è in cassaforte, non sono io la sua cassaforte.
Lei è tornata, non è mai andata via, è una Sirena che luccica, ha cantato e lo ha incantato.
‘L’ho rivista e la voglio ancora ‘.
Gretel, ha vinto il miraggio e tu lo sai.
Adesso è la Sirena ma prima o poi saranno una Madre impietosa, una Maga sapiente, una Tigre di seta, una Bambina con i denti grandi per mangiargli meglio il cuore.
Verranno, il lupo scrollerà il pelo d’argento e correrà da loro.
‘Non ho fatto lo scatto’.
Perché non si è acceso e lui vuole l’incendio, non vuole me.
Non ti vuole, non sei abbastanza magica.
Ancora una volta, l’ultima.
‘Sei così calda dentro, mi fai sentire sempre accolto’.
Sono la formica che vive di briciole, sono anonima come una geisha, porto offerte, cibo, il mio corpo, le mie nonlacrime per celebrare l’abbraccio da pitone e farmi ammazzare.
Con dolcezza però, perché il lupo è buono.
Non basto neanche così.
Ma dove sono la storia, il cuore, il mondo? La storia è questa, non c’è mai stata.
E’ bello questo incipit ma è una scusa, io ho questo da raccontare anche se non c’entra.
Baciami sugli occhi prima di andare via, fuori, nel cuore del mondo.
…………
‘Suberificazione’: in botanica, modificazione della parete delle cellule vegetali; tale modificazione si determina tutte le volte in cui i tessuti di un organo rimarrebbero indifesi per la caduta dell’epidermide, per la produzione di ferite, ecc..
A Paolo bambino albero lupo
“Boys don’t cry” (Marco Usai)
“Prima o poi entrerò nel cuore del mondo” era la frase che si era fatto tatuare l’estate della maturità. Parole ad effetto poco sopra le natiche, un’esca a caratteri gotici da aggiungere al piercing al sopracciglio che incorniciava lo sguardo scuro, fermo. Anche quando sorrideva, per lo più se in compagnia di qualche bella biondina glitterata, ad Alex restava appiccicato agli occhi qualcosa di malinconico. Mi faceva pensare a “Boys Don’t Cry”, con quel sound triste-allegro, tipo “vita innegabilmente amara ma stiamo quieti che così deve essere”. Insomma era un viveur con qualcosa di rotto dentro. Probabile che nei momenti felici gli capitasse di inciampare nel ricordo del fratello. Gli aveva insegnato i rudimenti dello stare al mondo per poi abbandonarlo senza neppure un ciao. Gente molto legata nonostante la differenza di età, con la stessa frase impressa sulla pelle, come uno stargate per l’aldilà, o forse un memo sul giungere al nocciolo di quel frutto succoso che la vita può essere solo a vent’anni. C’è chi pensava fosse solo un buffone esibizionista Alex, io credo che semplicemente provasse a seguire quel dettame lasciatogli in eredità. Certe sere s’impossessava di lui una follia gaudente e rabbiosa che a stargli accanto la vita poteva sembrare un gioco infinito. Passavamo nottate a esplorare stradine deserte, mentre la città dormiva rubavamo caschi e specchietti per rivenderli a pochi euro. Mi sentivo libero mentre gli facevo da spalla nell’ennesima rissa che scatenava per futili motivi, eravamo immortali anche nel tornare a casa con il viso segnato o mentre improvvisavamo un rally nelle mulattiere sopra Genova a bordo dell’auto sottratta a chissà quale schiavo sfortunato. Eravamo i sovrani di un mondo popolato da comparse in bianco e nero, in noi l’anarchia assumeva un significato più di stomaco che d’idea, eravamo i soli ad esser vivi… Fino a che mio padre non perse il lavoro. Quella che sarebbe dovuta essere la mia estate indimenticabile divenne quella in cui appresi le regole del giogo. Trovai impiego in un discount in periferia, la mia vita venne scandita da turni e pause caffè, pranzi cronometrati e anima scherzata da frustrati dalla vita. Era brutto ma era necessario, lavoravo molte ore e molte non mi erano pagate ma non c’era altra via. Avevo perso le ali e il mondo intorno perdeva colore, uscivo sempre meno spesso, la stanchezza veniva a riscuotere il suo conto. Alex era sempre lo stesso cercava, il cuore del mondo mentre io sistemavo scatolette. Mi veniva spesso a trovare e mi piaceva vedere come fosse ancora indomito, lui che non aveva crucci. Non lo invidiavo, era lo stendardo della mia anima sopita e adoravo quando rispondeva maleducatamente a miei superiori che mi bistrattavano nelle tediose ore salariate. Era un potenziale cliente, poteva tutto e mi tributava indirette rappresaglie che non tardarono a ritorcersi contro di me. Dovetti dirgli di non tornare a trovarmi a lavoro, la prese a male e non lo vidi più neppure fuori. I giorni passavano tutti uguali, lavoravo sempre, unica nota positiva di quei mesi fu la notizia del furto a danno del gran capo. Lo avevano alleggerito della sua moto da sogno, giusto mentre era parcheggiata sotto il discount.
Una sera uscii dopo mesi di ascetismo forzato, mi sentivo spaesato ma risi di gusto quando sotto casa trovai Alex in sella a quella stessa moto. La usava da settimane come fosse sua. Mi disse che si vive davvero solo intorno ai duecento orari o facendosi una tipa diversa ogni sera. Che io stavo al mondo come un morto. Sorrideva, sembrava volermi martoriare ma aveva gli occhi tristi, forse era ferito, forse si sentiva abbandonato. Non lo vidi più. Una mattina grigia d’autunno lessi un trafiletto che parlava di lui. Aveva perso il controllo di quella bestia da cento cavalli fuggendo dalla polizia. Mi piace pensare che abbia avuto un’estate indimenticabile, che almeno lui abbia vissuto il cuore del mondo che sogno ogni mattina.
“Ora e qui” (Licia Valente)
“Prima o poi entrerò nel cuore del mondo
lo farò
strisciando,
o in punta di piedi,
o spalancando la porta
da padrona.
Quando sarò entrata,
prima o poi
mi metterò a ascoltare.
E prima o poi
il mondo entrerà
nel mio cuore.”
Le ante dei mobili della cucina sono spalancate, il suo sedere spunta, tondo, dall’ultima a sinistra. È inginocchiata lì dentro insieme al caldo d’agosto da almeno venti minuti, non avrebbe mai immaginato di ritrovare, tra palline di polvere unta, rottami di pasta, briciole e qualche pesciolino d’argento mummificato, tutti i suoi ricordi.
In trent’anni è forse la prima volta che sta pulendo la sua casa. Prima non ne ha avuto il tempo né cercato l’occasione. Da qualche settimana però quel tempo si è fermato e lei con lui. Fermati da Dio, dai medici, dalla terapia e soprattutto dalla perenne spossatezza, puntuale alla fine della rabbia.
Oggi però ha deciso di accartocciare ogni speculazione, di tornare al suo vecchio pragmatico sé e di attuare un programma di riappropriazione. Di qualcosa, qualsiasi cosa, purché vicina, prossima, a portata di domani, anche se solo nella misura degli spazi fino ad ora sconosciuti del suo appartamento.
Il suo mondo è sempre stato fuori e altrove, mai dentro, o sotto, mai a portata di mano, o di cuore.
Nel tempo si è convinta che sia stata sua nonna, quella che le preparava l’uovo alla coque tiepido dentro il portauovo di peltro che ora stringe tra le dita, a convincerla dell’importanza di trovarsi un posto nel mondo. Donna antica, moglie di clausura, era diventata ambiziosa con le vite degli altri e sognava per lei, bambina moderna, un luogo ideale, lontanissimo e remoto, quello che avrebbe voluto per sé e non avrebbe raggiunto mai. Forse proprio allora, tenendo la mano di sua nonna, aveva iniziato ad addormentarsi cullandosi al pensiero di volare via.
Si è infilata in ogni anfratto, si è coricata sotto la tazza del bagno, ha raccolto calzini ormai plastificati, pupazzetti rattrappiti e biglietti di cinema con titoli che non ricorda. Ha sfilato dal battiscopa forcine per i capelli che non ha più e una fotografia che l’ha fatta commuovere e che ha perso di nuovo.
Nella calma lenta delle nuove giornate, senza scadenze da litigare, né post-it nevrotici, sono i ricordi a cui non ha mai fatto caso a venirle incontro ancora vitali, pulsanti, ancora vuoti di rimpianto.
Le litanie della nonna risalgono dal fondo del cassetto con l’odore di pane secco. Non dare confidenza, non fidarti delle apparenze, studia e non accontentarti, non farti mantenere da nessuno.
Trova il tuo posto nel mondo.
È sempre stata convinta che quello fosse l’invito. Ma ora non ne è più sicura.
La voce che sale dal pane ha parole nuove.
Non è un generico posto nel mondo a cui la sta invitando, è dentro il suo cuore che la chiama ora, a fermarsi nel cuore del mondo, entrandoci come nella madia, a quattro zampe, sfatta di sudore, pronta a restare.
Non si è mai infilata in nulla. Nella vita di prima scivolava via, cogliendo qua e là il senso imperfetto di cose preferibilmente fuggevoli, così il suo posto nel mondo era diventato mille luoghi dove non mettere mai radici, perché le radici sono comunque velenose.
Ora, ferma, in ginocchio, davanti alla madia, le pare di intravvedere il suo posto nel mondo lì dentro, nel cuore del suo mondo, così piccolo e prossimo a finire.
“Il cuore del mondo batte in una casa di carta, colorata a pennarello: ha i muri rosa, una porta verde, quattro finestre quadrate e in centro, sopra la porta, un oblò. Un comignolo posato a sghimbescio sul tetto e, dietro, un albero blu, perché il verde era sempre scarico.”
Quel disegno lo hai conservato sul fondo del tuo comodino. Da bambina lo nascondevi sotto il cuscino, quando per addormentarti sognavi di volare via, ma sotto la testa volevi una casa che ti stesse ad aspettare.
Un albero. Non hai mai pensato di comprarne uno.
Afferri il cellulare, chiami tuo marito.
Puoi portarmi un albero, questa sera? Se non lo trovi verde, blu può andare bene.