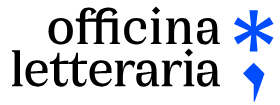Nella guida di Londra che ho comprato tengo il segno sulla pagina della Westminster Abbey. C’è scritto che qui sono sepolti ventotto sovrani e più di cinquanta grandi personalità della storia dell’arte, della letteratura e della tecnica. Gente che ha lasciato un segno imperituro.
Sopravvissuti
di Andrea Suma
E io? Io sono qui, in mezzo a loro, nel cuore prospettico della croce latina, con la guida da 14,99 in mano e l’indice infilato tra le pagine, perché il segnalibro che ho comprato in quella bancarella di souvenir, figuriamoci, l’ho già perso. Chissà dove l’ho lasciato. Da qualche tempo dimentico tutto. La morte dà così tanto da pensare che non riesco a organizzarmi più come prima e dimentico persino il bagaglio a mano sull’aereo. Meno male che Giulia, come sempre, è qui con me, in un questo viaggio post laurea, a ricordarmi del bagaglio a mano, a ricordarmi del mio spazio umano incatenato alle piccole incombenze quotidiane.
Eccomi qui, all’incrocio tra la navata e il transetto, una ragazza convinta di poter morire da un momento all’altro dopo sole ventiquattro primavere una laurea e niente di straordinario, schiacciata da due dimensioni: quella orizzontale dei morti che non sono morti, della gente che ha lasciato un segno imperituro, e quella verticale delle crociere goticheggianti, campate che toccano il cielo, molto più alte più vecchie più durature più importanti di me.
Mi guardo attorno e il mio cuore, il mio ritmo su questa terra, è sempre più veloce, fibrilla come un pazzo.
Cerco di respirare per placarlo ma l’aria è densa e immobile e lui corre senza briglie, vuole scappare via da me.
Aspetta cazzo, non sono pronta, non ora! Aspetta!
Il pavimento della navata mi sembra si inclini, mi manca l’equilibrio; le navatelle si inviluppano, vogliono farmi scivolare giù, insieme ai morti che sono davvero morti, milioni di vite che non lasciano il segno. No, non ci sto. Ho solo una laurea ventiquattro primavere e niente di straordinario, non sono pronta. Devo correre verso l’uscita e mettermi in salvo.
“Nella vita bisogna ascoltare il proprio cuore”, ci dice la retorica, e qualcuno si sente forse rassicurato, ma nessuno sa bene cosa significhi. Io invece sì.
Sin da bambina sono sempre riuscita ad ascoltare il mio cuore. Ben presto ho scoperto che non era una cosa da tutti e ho iniziato ad esserne orgogliosa. Ero decisamente più avanti dei miei coetanei e credo dipendesse anche da questo: sentire il funzionamento involontario di un organo interno, in un battito ritmico e rumoroso, dà una profonda coscienza di sé. In più erano battiti giovani, battiti forti che picchiavano insolenti contro il petto.
Amo lo sport dal mio primo respiro. Sono sempre stata la numero uno, mi piaceva esserlo. Vincere non era il superamento dell’altro, ma la sperimentazione del corpo, che portavo al massimo per sentire forte e chiaro quel battere sordo dentro di me: “sono qui, sono viva, lo sarò per sempre.”
Quasi quasi non ti ascolto.
Quasi quasi ho il vomito.
Quasi quasi esagero.
Se mi sopravvaluto.
Anche a Giulia piacciono i Subsonica e cascasse il mondo non ci perdevamo un concerto, ma quella sera c’era qualcosa che non andava. Nulla di grave, sentivo il mio cuore come sempre, anche in mezzo a quel casino, ma Cristo come mi bruciavano gli occhi!
La mattina dopo me li sentivo talmente grossi e pesanti che credevo mi cascassero.
L’apprensione nella voce di mio padre era una nota per me sconosciuta, per questo me ne ero fidata ciecamente e avevo acconsentito senza fiatare.
Il medico era un amabile dinosauro prossimo alla pensione, uno di quelli che ancora “ascolta” il corpo del paziente.
Parlava con lui, lo toccava, lo picchiettava, ascoltava silente il suo rumore e ne decifrava concentrato i segnali. Mi era venuta un’infezione agli occhi; sicuramente la colpa era delle lenti a contatto. Avevo stabilito che era meglio scegliere un bel paio di occhiali, magari con una bella montatura tartarugata e un taglio da intellettuale. Dopotutto ero quasi una dottoressa, visto che mancavano solo tre settimane alla laurea. Ci voleva un bel paio di occhiali.
“Perché? Cos’ha che non va?”. Che stronzate, il mio cuore stava benissimo.
“Perché ha un battito molto forte. È anomalo. Sicuramente non è nulla, ma è meglio sincerarsene”.
Era stato mio padre a rispondere. Io ero talmente incredula da non riuscire a proferire nemmeno le più banali formule di cortesia.
Il cardiologo era un aitante quarantenne brizzolato con gli occhi arroganti. Seguivo con lo sguardo il suo incedere sicuro mentre, cartella alla mano, entrava nello studio in cui noi eravamo già seduti da un pezzo, chiudeva la porta e si accomodava sulla sua sedia imbottita. Mi ricordo quei dieci secondi in cui aveva fatto finta di leggere i risultati delle analisi.
Mi ricordo che aveva alzato gli occhi arroganti e aveva guardato i miei con il rimprovero per un peccato che non sapevo di avere commesso.
No, non me n’ero resa conto. Peccato mio. Peccato mio pensare di essere invincibile, credere che un cuore che fa un rumore forte è un cuore che vive forte. Adesso che sono corsa fuori dall’abbazia, con il cuore l’affanno e il vomito in gola, lo so che sono sopravvissuta, ancora un altro giorno. Mi guardo intorno, guardo tutti questi individui che, grazie ai loro cuori silenziosi, sopravvivono senza saperlo.
Beati loro.